| | | OFFLINE | Post: 39.988 | Sesso: Femminile | |
|
 21/05/2015 13:41 21/05/2015 13:41 | |
 un grande maestro e un santo pastore d'anime..... un grande maestro e un santo pastore d'anime.....
Biografia
 Nato a Milano il 13 giugno 1928, ha compiuto gli studi ecclesiastici nei Seminari dell'Arcidiocesi Ambrosiana ed è stato ordinato Sacerdote a Milano il 23 dicembre 1950 dall'Arcivescovo card. Alfredo Ildefonso Schuster. Laureatosi in Teologia nel 1955 con una tesi su "La colpa e la libertà nell'odierna condizione umana", ha insegnato per alcuni anni nei Seminari dell'Arcidiocesi milanese. Dal 1960 al 1969 è stato Parroco ai Ss. Martiri Anauniani, a Legnano, e dal 1969 al 1975 a S. Andrea, a Milano. L' 11 febbraio 1975 è stato nominato Canonico Teologo del Capitolo Metropolitano di Milano. Nato a Milano il 13 giugno 1928, ha compiuto gli studi ecclesiastici nei Seminari dell'Arcidiocesi Ambrosiana ed è stato ordinato Sacerdote a Milano il 23 dicembre 1950 dall'Arcivescovo card. Alfredo Ildefonso Schuster. Laureatosi in Teologia nel 1955 con una tesi su "La colpa e la libertà nell'odierna condizione umana", ha insegnato per alcuni anni nei Seminari dell'Arcidiocesi milanese. Dal 1960 al 1969 è stato Parroco ai Ss. Martiri Anauniani, a Legnano, e dal 1969 al 1975 a S. Andrea, a Milano. L' 11 febbraio 1975 è stato nominato Canonico Teologo del Capitolo Metropolitano di Milano.
Già Vicario Episcopale per la Cultura dal 1974, ha ricevuto nel 1975 la nomina a Direttore dell'Istituto Lombardo di Pastorale, ricoprendo anche l'incarico di responsabile della Commissione per il Rito Ambrosiano.
Il 7 dicembre 1975 è stato eletto da Paolo VI Vescovo titolare di Fidene e deputato Ausiliare del card. Giovanni Colombo, Arcivescovo di Milano, che lo ha consacrato Vescovo l'11 gennaio 1976 nella Chiesa parrocchiale di S. Andrea, a Milano.
Dal 1976 al 1982 ha fatto parte della Commissione episcopale della C.E.I. per la dottrina della fede, la catechesi e la cultura, di cui è stato Segretario dal 1979 al 1982. Inoltre nel 1982 è stato eletto fra i componenti la Commissione Episcopale per la Liturgia.
Promosso Arcivescovo di Bologna il 19 aprile 1984, ha preso canonico possesso dell'Arcidiocesi il primo giugno 1984, facendovi solenne ingresso il giorno successivo, 2 giugno. Il 7 luglio dello stesso anno è stato eletto Presidente della Conferenza Episcopale Emilia-Romagna.
Creato e pubblicato Cardinale prete del Titolo dei Ss. Giovanni Evangelista e Petronio a Campo de' Fiori da Sua Santità Giovanni Paolo II nel Concistoro del 25 maggio 1985, è membro della Congregazione per il Clero e della Congregazione per l'Educazione cattolica.
Ha lasciato il governo dell'Arcidiocesi bolognese, per raggiunti limiti di età, il 16 dicembre 2003. È stato Amministratore Apostolico dell'Arcidiocesi dal 16 dicembre 2003 al 15 febbraio 2004.
Nel 1989 ha predicato gli esercizi spirituali al Santo Padre Giovanni Paolo II e alla Curia romana e nel 2007 ha predicato gli esercizi spirituali al Santo Padre Benedetto XVI e alla Curia romana.
È autore di numerose pubblicazioni a carattere teologico e catechetico.

Genealogia Episcopale
Giacomo Biffi 11 gennaio 1976
Giovanni Colombo 7 dicembre 1960
Giovanni Battista Montini (Paolo VI) 12 dicembre 1954
Eugenio Tisserant 25 luglio 1937
Eugenio Pacelli (Pio XII) 13 maggio 1917
Giacomo Della Chiesa (Benedetto XV) 22 dicembre 1907
Giuseppe Sarto (Pio X) 16 novembre 1884
Lucido Maria Parocchi 5 novembre 1871
Costantino Patrizi 21 dicembre 1828
Carlo Odescalchi 25 maggio 1823
Giulio Maria Della Somaglia 21 dicembre 1788
Giacinto Sigismondi Gerdil 2 marzo 1777
Marcantonio Colonna 25 aprile 1762
Carlo Rezzonico (Clemente XIII) 19 marzo 1743
Prospero Lambertini (Benedetto XIV) 16 luglio 1724
Vincenzo Maria Orsini (Benedetto XIII) 3 febbraio 1675
Paluzzo Paluzzi-Albertoni-Altieri 2 maggio 1666
Ulderico Carpegna 7 ottobre 1630
Luigi Caetani 12 giugno 1622
Lodovico Ludovisi 2 maggio 1621
Galeazzo Sanvitale 14 aprile 1604
Girolamo Bernerio 7 settembre 1586
Giulio Antonio Santorio 12 marzo 1566
 attualmente - alla guida della Diocesi - c'è un altro e davvero grande cardinale, il successore di Biffi, Carlo Caffarra. attualmente - alla guida della Diocesi - c'è un altro e davvero grande cardinale, il successore di Biffi, Carlo Caffarra.
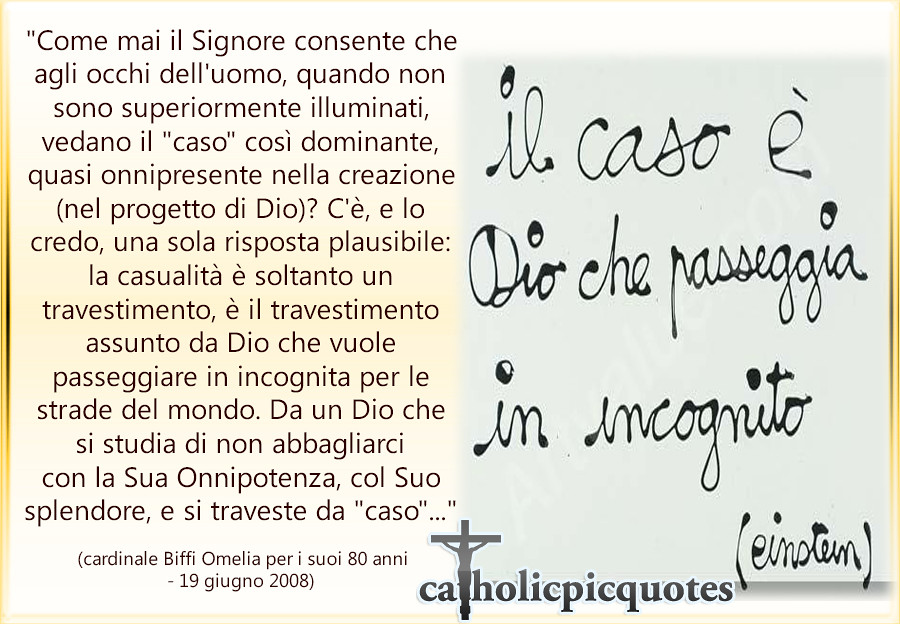
OMELIA NELLA S. MESSA CONCELEBRATA DAL CLERO DIOCESANO
CHE RICORDA IL GIUBILEO DI ORDINAZIONE
DAVANTI ALL'IMMAGINE DELLA MADONNA DI S. LUCA
Giovedì 13 maggio 1999, ore 11.30
Oggi è per noi uno dei giorni più belli e più cari: la nostra città e la nostra diocesi oggi celebrano solennemente la loro patrona, che con immancabile puntualità da oltre cinque secoli discende e si insedia nel cuore di Bologna, quasi a ricordare a tutti, anche visivamente, che è lei la Signora del popolo petroniano, "il segno della nostra difesa e del nostro onore".
Nessun giorno dell’anno è anche così propizio per noi a riflettere – sotto il dolce sguardo della sua icona antica – sulla collocazione della Vergine benedetta entro il disegno del Padre e sul suo compito proprio nella vita e nella società dei credenti.
La più elementare e insieme la più esauriente notizia ci viene data da Maria stessa con le parole semplici e sublimi dette al messaggero di Dio: "Io sono la serva del Signore" (Lc 1,38).
Giustamente si autodefinisce "serva del Signore" colei che visse unicamente per fare la volontà del Signore. Stava in ascolto della sua parola, la custodiva con fede pura, la metteva in pratica con intemerata fedeltà. Così la Parola vivente, il Verbo eterno di Dio, prese volentieri umana carne da lei, perchè lei aveva sempre incarnato nel suo essere e nel suo agire ogni parola che Dio o le andava comunicando nell’ascolto della Sacra Scrittura o le andava sussurrando nel segreto del suo mondo interiore.
"Serva del Signore"
Servire il Signore era per Maria anzitutto credere in Dio, adorarlo, amarlo sopra ogni cosa; ma al tempo stesso era soccorrere il prossimo nel bisogno.
Servire il Signore era mettersi in viaggio verso la montagna con passo premuroso, alla casa di un’anziana parente da aiutare nella sua inattesa maternità.
Servire il Signore era andare a Cana, e togliere due sposi dal disagio e dall’imbarazzo durante il banchetto nuziale.
Servire il Signore era per Maria preannunziare con le sue scelte esistenziali e con il suo canto profetico la grande rivoluzione delle coscienze, che il bambino custodito nel suo grembo avrebbe operato nella storia. Dalle labbra appunto di questa ignota fanciulla ebrea, che era la più mite e la più santa delle creature, si eleva il "Magnificat" a proclamare la fine delle ingiustizie, delle prepotenze, delle oppressioni e a inaugurare il tempo nuovo del Regno di Dio; il tempo in cui comincia a esultare il cuore dei poveri, e sorge un po’ di speranza per i disprezzati di questo mondo.
* * *
"Fate quello che vi dirà" (Gv 2,5). La missione provvidenziale di Maria presso gli uomini è di invitarli e incoraggiarli ad accogliere la parola dell’unico Salvatore e a metterla in pratica.
Il Signore Gesù ha detto: "Nessuno può venire a me, se non l’attira il Padre che mi ha mandato" (Gv 6,43). Nel piano divino di salvezza – connotato intrinsecamente dalla misericordia e dalla condiscendenza – la Madonna è stata pensata e voluta proprio come una soave e persuasiva forza di attrazione, perchè anche i più riottosi figli di Adamo avessero modo di arrivare a Cristo.
I nostri contemporanei così scettici di fronte alla luce della verità, così orgogliosi delle loro conquiste scientifiche e tecniche, così avidi di beni di consumo e così disamorati dei beni eterni, così presi dalla fame di danaro, di godimento, di potere e così disorientati e disanimati , pare che solo dal fascino della Madre di Dio, che è madre anche nostra, possano essere scampati dalla tremenda sventura di ripiombare in un mondo senza Cristo; cioò un mondo senza certezze trascendenti, senza vera gioia, senza tensione verso un traguardo non deludente.
Al fuoco di un puro amore materno, reso soprannaturalmente efficace dalla potenza dello Spirito Santo, è più facile che le torpidità delle menti e le durezze dei cuori si fondano e si dissolvano.
L’incanto di questa donna umile e alta – modello inarrivabile di perfezione, che però resta sempre totalmente una di noi – avvicina con gentilezza femminile alla nostra piccolezza, alle nostre titubanze, alla difficoltà che abbiamo di sollevare lo sguardo dalla terra, l’unica, necessaria, salvifica mediazione di Cristo.
La Madonna è madre: ama, consola, aiuta i suoi figli anche nelle necessità della loro vita terrena per farli diventare autentici e consapevoli figli di Dio. Li prende dove sono per portarli dove dovrebbero essere, cioè vicini a Gesù nella mentalità e nelle opere.
Perciò i suoi santuari e le celebrazioni in suo onore sono i luoghi e o tempi privilegiati per il ritorno dei figli smarriti alla casa del Padre.
* * *
La Chiesa non può dimenticare di aver mosso i primi passi nella storia con il sostegno della presenza visibile di Maria.
Il mattino di Pentecoste, nel cenacolo, la preghiera appassionata di Maria era il culmine e la sintesi di tutte le implorazioni dei discepoli di Gesù, anzi dell’umanità intera che invocava sul proprio buio, sulle proprie frigidità, sulle proprie miserie il fulgore, il calore, l’impeto del Paràclito e la sua effusione vivificante e rinnovatrice.
Agli apostoli la Madre di Gesù confidava i segreti divini che custodiva nel suo cuore, entusiasmandoli per la sapienza e la bellezza sovrumana del progetto del Padre.
Anche per questo gli inizi del cristianesimo furono così pieni di fervore e segnarono progressi tanto rapidi e stupefacenti.
Seppure assunta al cielo, collocata regina accanto al Figlio, non si è allontanata da noi.
E' sempre con noi, e nei momenti più trepidi per la vita della Chiesa il suo amore materno si è sempre fatto sentire.
Quando pare che le ostilità e gli errori siano soverchianti, più grande si fa la fiducia dei credenti. Quando nel nostro cielo sembrano dominare le tenebre, spunta a darci coraggio la sua vivida stella.
Così nell’incerto e annebbiato tramonto del secolo, anzi del millennio – nella grande confusione che prende persino i cristiani a proposito del Signore Gesù e della sua redenzione universale e universalmente necessaria; a proposito della Chiesa, della sua indefettibile santità e della sua natura di "universale sacramento di salvezza"; a proposito del vero bene dell’uomo, del suo destino, della sua dignità – volgiamo gli occhi a lei con animo pieno di gratitudine e di speranza.

Bologna, 11 luglio 2015 - E’ morto questa notte Giacomo Biffi, 87 anni, arcivescovo emerito di Bologna. Biffi è stato arcivescovo della città dal 1984 al 2003. Era ricoverato in una clinica bolognese dopo un intervento chirurgico subito nel maggio scorso.
Biffi si è spento alle 2,40 della scorsa notte. Aveva compiuto 87 anni lo scorso 13 giugno e recentemente aveva ricevuto anche una lettera di Papa Francesco : «Sono stato informato delle Sue condizioni di salute e desidero esprimerLe la mia profonda vicinanza in questo momento di sofferenza», aveva scritto Bergoglio.
La biografia. Giacomo Biffi è nato a Milano, città metropolitana e sede arcivescovile, il 13 giugno 1928. Ha ricevuto l'ordine sacro del sacerdozio a Milano il 23 dicembre 1950. È stato insegnante di teologia e parroco a Legnano nella parrocchia di S.S. Martiri e quindi a Milano nella parrocchia di Sant'Andrea. Papa Paolo VI lo ha nominato vescovo titolare di Fidene e ausiliare del cardinale arcivescovo di Milano il 7 dicembre 1975; ha ricevuto l'ordinazione episcopale l'11 gennaio 1976. Promosso arcivescovo di Bologna, vi fece il solenne ingresso il 2 giugno 1984. Elevato al rango di cardinale da papa Giovanni Paolo II nel concistoro del 25 maggio 1985, è stato membro della Congregazione per l'evangelizzazione dei popoli, della Congregazione del clero e della Congregazione per l'educazione cattolica. Ritiratosi nel 2003 per raggiunti limiti d'età, conserva il titolo di arcivescovo emerito di Bologna. Nel 2007 ha tenuto gli esercizi quaresimali alla Curia romana e a Benedetto XVI. Dal 13 giugno 2008, avendo compiuto l'ottantesimo anno d'età, non è più un cardinale elettore.
Le frasi celebri. Storica quella del 1985 quando definì Bologna «sazia e disperata» (leggi tutte le frasi celebri), espressione che lo rese famoso anche fuori dei confini emiliani
La curiosità. Si racconta di un episodio molto divertente che avvenne durante il conclave del 2005 che ha come protagonisti proprio il cardinale Biffi e il futuro Benedetto XVI, seppur in modo indiretto. A raccontare l'accaduto è il giornalista cattolico Francesco Grana, noto commentatore di fatti religiosi e notoriamente vicino all'allora arcivescovo di Napoli, il cardinale Michele Giordano. È il 19 aprile 2005, secondo e ultimo giorno di votazioni. Dopo il terzo scrutinio del conclave, il secondo di quella mattina, i cardinali elettori tornano in pullman nella Casa Santa Marta dove risiedono in quei giorni. Li attende il pranzo e un breve riposo nelle loro stanze prima di far ritorno nella Cappella Sistina per la votazione che sarà definitiva e alla quale seguirà l'annuncio al mondo dell’avvenuta elezione del nuovo Papa. Ed è proprio durante quel pasto frugale che Biffi, molto innervosito, si sfoga con un confratello: «A ogni votazione ricevo sempre un solo voto. Se scopro chi è che si ostina a votarmi giuro che lo prendo a schiaffi». «Cosa Eminenza?», gli domanda perplesso il confratello. «Sì, ha capito bene, Eminenza», replica Biffi. «Giuro che lo prendo a schiaffi». Al che il porporato lo guarda perplesso e gli spiega: «Eminenza, ormai è chiaro chi stiamo eleggendo come nuovo Papa ed è anche abbastanza evidente che questo candidato abbia scelto di votare per lei. Quindi se vorrà ancora mantenere il suo proposito sarà costretto a prendere a schiaffi il Papa». Biffi rimase senza parole.Ratzinger aveva deciso di votare per lui.
La pagina Facebook. «11 luglio 2015. Riposa in pace! 'Dopo, c'è Cristo; di là dallo schermo delle cose, c'è Cristo; alla fine di tutto, c'è Cristo»'. E' la frase, presa da un libro scritto dallo stesso Biffi, apparsa in mattinata su una pagina Facebook, che raccoglieva gli interventi del cardinale.
di Luca Orsi 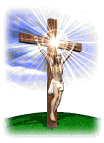 [Modificato da Caterina63 11/07/2015 12:28] Fraternamente CaterinaLD
"Siamo mendicanti e chiediamo agli altri anche le loro idee, come la staffetta della posta che riceve il documento dalle mani di uno e poi corre per darlo ad un altro. Faccio una timida parafrasi delle parole di chi ci ha preceduto nel cammino della fede, per annunciarle ad altri."
(fr. Carlos Alfonso Azpiroz Costa OP
Maestro dell’Ordine) |
|
| | | OFFLINE | Post: 39.988 | Sesso: Femminile | |
|
 21/05/2015 14:15 21/05/2015 14:15 | |
 OMELIA IN OCCASIONE DELLA "PASQUA DEGLI UNIVERSITARI" OMELIA IN OCCASIONE DELLA "PASQUA DEGLI UNIVERSITARI"
Martedì, 23 marzo 1999, ore 18,30, Cattedrale di San Pietro
Il titolo di "maestro" nei Vangeli viene dato a Gesù con molta frequenza, anche da chi, più che delle illuminazioni, a lui chiede dei benefici. Gesù non ha alcuna riserva verso questo titolo e lo accetta come dovuto: "Voi mi chiamate Maestro e Signore e dite bene, perché lo sono" (Gv 13,13). Anzi se lo rivendica in modo esclusivo: "Uno solo è il vostro maestro, il Cristo"(Mt 23,10).
Cristo è l'unico maestro prima di tutto per una ragione oggettiva: perché in lui si compendia il disegno eterno del Padre. Poi perché di questo disegno è il grande rivelatore.
Andando dunque alla sua scuola e meditando su tutto ciò che ha fatto e su tutto ciò che ha detto, noi cresciamo nella comprensione del "mistero nascosto da secoli e da generazioni, ma ora manifestato ai suoi santi" (Col 1,26); e possiamo "conoscere l'amore di Cristo, che sorpassa ogni conoscenza" (Ef 1,19).
Avere a disposizione un maestro come il Signore Gesù è una fortuna di cui dobbiamo renderci conto, e una ragione di gioia, che non va mai dimenticata. Noi troviamo qui il fondamento delle nostre rasserenanti certezze, che, in mezzo al pullulare dei dubbi e delle insipienze, ci consentono di continuare a vivere da creature razionali.
"Uno solo è il vostro maestro": non ci sono altri maestri che siano veramente tali.
Tutti gli altri insegnamenti o non conducono alla verità (e dunque non sono autentici insegnamenti) o conducono a verità esistenzialmente irrilevanti o, in ultima analisi, derivano la loro autorevolezza, magari inconsciamente, da lui. E questa unicità di magistero ci salva dalla "dissensio sententiarum", cioè dalla contrastante e disorientante varietà delle opinioni correnti.
Questo è il maestro mandato proprio per noi, per farci uscire dallo scoraggiamento e dall'avvilimento che spesso insidiano i ricercatori della vera conoscenza, costretti a vivere immersi in una cultura scettica che sembra impegnata soprattutto ad annunciare il vuoto e l'assurdo. E questo ci scampa dalla "desperatio inveniendi verum".
Ma non basta avere il Maestro giusto. Bisogna anche andare alla sua scuola. "Ascoltatelo!" (cfr Mt 12,5), ci dice la voce del padre. Mettersi in posizione di ascolto davanti a Gesù è ciò che ci proponiamo di fare in questi giorni, ed è ciò che vogliamo fare con più impegno, più assiduamente, più a lungo nella nostra vita.
Che cosa ci insegna Cristo? Ci insegna tutto, tanto che, dopo la sua venuta nel mondo, la rivelazione di Dio si è conclusa, si è conclusa non per un'arbitraria volontà del Padre che ha deciso di ammutolirsi, ma perché, avendo mandato il figlio nel quale l'intero suo disegno si compendia, non aveva più niente da dirci per questo ordine di provvidenza.
Se però ci domandiamo: quali sono gli argomenti che più insistentemente di ogni altro sono presenti nei discorsi del Signore Gesù, non ci sono dubbi: sono il Padre e il Regno. Non c'è pagina di Vangelo dove l'uno o l'altro o tutti e due non facciano capolino.
Ci limitiamo qui a raccogliere solo l'insegnamento sul Padre.
Il Padre.
Dalla prima sua parola che ci è stata riferita ("Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?" Lc 2,49) fino alla suprema offerta della croce ("Padre nelle tue mani consegno il mio spirito" Lc 23 46) Gesù parla continuamente di Dio e a Dio sempre qualificandolo "Padre". Questa è l'esperienza gioiosa fondamentale della sua vita interiore di uomo il vertice della sua conoscenza creata: "Io ti ho conosciuto" (Gv 17,25). Ed egli è anche ben consapevole che la sua è un esperienza unica e una conoscenza imparagonabile: "Nessuno conosce il Padre se non il Figlio" (Mt 11,27).
Da questa intuizione primigenia l'intuizione, cioè, che Dio ci è Padre - deduce la possibilità per l'uomo di guardare il mondo e di affrontare la vita senza affanni e con inalterabile serenità (cfr Mt 6,25-34). Dalla paternità di Dio nasce il convincimento della inesauribile propensione al perdono, propria del Creatore, che lo rende sempre pronto ad abbracciare i figli sviati che ritornano a lui pentiti, qualunque cosa abbiano fatto (cfr la parabola del Figlio prodigo, Lc 15,11-32).
E Gesù riesce a parlare in termini così appassionati e persuasivi del Padre, perché il Padre è il suo più assiduo e ricercato interlocutore, al quale riserva uno spazio esclusivo anche nei suoi giorni più affaccendati.
Questo insegnamento di Gesù rimane di spiccata attualità. Anche oggi la questione prima e più decisiva per l'umanità è quella di riscoprire la Paternità di Dio.
Di solito si dice - e c'è moltissima verità in questa affermazione - che la difficoltà più grave è di accettare la Chiesa: Cristo sì, Chiesa no, sarebbe la posizione di molti.
A un secondo livello, si nota - e anche qui c'è molto di vero - che è più facile trovare chi crede in Dio, che non trovare chi crede in Gesù di Nazaret e nella verità assoluta del suo Vangelo.
Io però non ho mai trovato nessuno, almeno nella popolazione di tradizione cattolica, che, rifiutando la Chiesa, poi accolga Gesù Cristo per quello che è; cioè come Figlio di Dio fatto uomo, crocifisso, risorto, oggi vivo. E non ho mai trovato nessuno che, rifiutando Cristo nella sua verità creda poi nel Padre; cioè, non in un Dio indifferente e lontano, ma nel Dio che c'è, che interviene nella nostra vicenda, che decide lui che cosa è bene e che cosa è male, che è offeso nel suo amore dalle nostre colpe, che ci ha assegnato come destino la sua stessa casa. Mi sono fatto perciò l'idea che la cosa più ardua e più necessaria per l'uomo di oggi è appunto quella di ritrovare il Padre. Chi arriva al Padre, presto o tardi arriva a colui che il Padre ha inviato per la nostra salvezza, e chi arriva a Cristo Dio e Salvatore, presto o tardi arriva a capire la bellezza della sua Chiesa.
Per una umanità "fraterna"
Solo ritrovando il Padre (e poi accogliendo il suo progetto centrato sulla croce) si può accettare il mondo stravolto e crudele in cui ci è capitato di vivere.
Il mondo - che pure, se correttamente esaminato sotto il profilo filosofico rimanda necessariamente a un Creatore - troppe volte ci appare come una smentita all'esistenza di Dio, se è guardato nelle sue condizioni esistenziali.
Solo la fede che il Creatore è anche un Padre e ha sull'uomo un suo disegno incomprensibile e strano, ma in ogni caso ispirato dall'amore, un disegno in cui c'è posto per il peccato, per il dolore, per la sofferenza redentrice del Figlio di Dio, per il mistero della croce, riesce a farmi riconnettere il mondo alla sua Causa prima e a farmi ritenere che esso non sia un'assurdità. E dunque solo l'idea del Padre mi consente di convincermi che esiste una superiore ragionevolezza, cioè mi consente di esistere da uomo.
Va detto inoltre che solo ritrovando il Padre gli uomini possono sperare di convivere senza che il loro egoismo porti l'umanità all'autodistruzione.
Solovëv ha scritto da qualche parte che tutti i socialismi del suo secolo erano basati su questo curioso sillogismo: tutti gli uomini derivano dalla scimmia, dunque dobbiamo amarci tutti come fratelli. Credo che il giudizio di Solovëv colpisca nel segno: dalla fine del secolo XVIII è in atto il tentativo di salvare e attuare la conclusione cristiana, sostituendo alle premesse cristiane delle premesse scientiste. Il secolo XX - che è stato il secolo dei più vasti e ripetuti massacri tra gli uomini e delle società politiche più disumane - si è tragicamente incaricato del compito di dimostrare che il ragionamento non sta in piedi.
Se vogliamo vivere da fratelli e salvarci, dobbiamo ripartire dal Padre. E questo vale anche per la nostra vita spirituale. Gesù ci insegna che la prima, la più alta, la più necessaria delle devozioni è la devozione al Padre. Il senso di Dio e della sua paternità non può mai essere sottinteso nella nostra vita religiosa, ma deve offrire la premessa esplicita per ogni altro impegno e per ogni altro amore.

OMELIA NELLA SOLENNITÁ DEL CORPUS DOMINI
Giovedì 3 giugno 1999, ore 21.15, Sagrato Basilica S.Petronio
La celebrazione di questa sera, il nostro camminare pensoso e lieto per le strade della città che si sono fatte assorte e quasi oranti con noi, il nostro sostare in preghiera, ci aiutano a riscoprire la forza sempre giovane ed efficace dell'eucaristia: l'attualità cioè di una "parola" che è luce di verità ed energia di grazia: di una "parola" che è anche avvenimento salvifico; di una "parola" che è soprattutto una "persona": una "persona" totalmente donata - con la sua "carne" e col suo "sangue" - per la vita del mondo (cf Gv 6,51).
"Le parole che io vi dico sono spirito e vita" (Gv 6,64), afferma Gesù. Come a dire: voi ascoltate ogni giorno parole vane e talvolta addirittura parole mortifere; dalle mie parole invece potete attingere un nutrimento autentico e sostanziale.
Terribile è nelle parole umane la capacità di illudere, di ricamare sogni fascinosi sulla tela del nulla, di erigere castelli in aria che alla luce della verità e al maturare dell'esperienza si dissolvono come nebbia al sole, lasciando il cuore deluso e amareggiato.
Terribile è il maleficio di certe parole sordide e avvilenti, le quali, anche quando sono udite incolpevolmente, lasciano nell'uomo l'impressione di essere stato contaminato.
Terribile è il condizionamento e perfino il plagio di certi slogan e di certe frasi ossessivamente martellate, che non esprimono neanche un briciolo di ragionamento o di saggezza.
Ma noi, che crediamo nell'eucaristia, siamo alla scuola della Parola vivente, parola divina e rivestita di accenti umani, parola eterna ed echeggiata per nostra fortuna nel tempo. Infondendoci "spirito e vita", essa ci fa uomini liberi, ci sottrae alla schiavitù del linguaggio falso e alienante, ci ridona la nostra nativa attitudine a valutare, a scegliere , a decidere.
Questa è parola che mantiene ogni sua promessa, che non delude mai, che consola gli animi feriti dai giudizi degli altri; giudizi spesso senza comprensione e impietosi.
Essa risuona in tutta la sua potenza trasformante, quando l'ascoltiamo in silenzio e ci disponiamo ad aprirci con docilità al suo magistero.
Ogni custodito raccoglimento interiore può favorire questa emozionante comunione con il Verbo del Padre. Ma la condizione più propizia a questa vitale attenzione della mente e del cuore ci è offerta dal silenzio adorante, di cui circondiamo la presenza eucaristica. Sembra una presenza muta, ed è in realtà la più eloquente, perché ci pone a contatto non solo con l'insegnamento salvifico, ma anche con lo stesso nostro Salvatore e Maestro.
Anche le pagine del Libro sacro - non dissimili in di apparenza da quelle inerti tutti gli altri libri - quando sono lette al cospetto del mistero eucaristico, risplendono e si infiammano per opera dello Spirito, che l'Ospite dei nostri altari e dei nostri tabernacoli effonde dalla sua pienezza su chi gli è davanti in ascolto intento e affettuoso.
*** *** ***
La Parola vivente del Padre, presente nell'eucaristia , va accolta e assaporata nel segreto dell'anima. Però non possiamo mai dimenticare che essa ci è data "per la vita del mondo". Il silenzio adorante è quindi la premessa e il continuo alimento dell'annuncio, dell'ansia evangelizzatrice, della testimonianza esistenziale.
Mai come oggi l'umanità aspira alla "vita"; e mai come oggi la insidia e sembra quasi disistimarla.
L'età media si prolunga sempre più, si combatte la morte con interventi chirurgici prodigiosi, la cura della buona forma e della salute è diventata una specie di religione ossessiva. Ma tutto ciò è contrastato e quasi smentito dall'imperversare delle guerre, dalle stragi ideologiche, dagli attentati fanatici e vili, dalle vergognose leggi contro le creature umane che ancora non hanno visto la luce, dall'incoscienza con cui spesso si circola sulle nostre strade.
Anche la diffusione della droga e la ridicola sessuomania che domina la cultura del nostro tempo danno il loro contributo a una incomprensibile autodistruzione dell'uomo.
Questo spettacolo desolante - che ci preoccupa e ci addolora - dà certo una pena infinita anche al cuore di Cristo. Egli però non ci abbandona, non ci abbandona mai quali che siano le nostre prevaricazioni e le nostre insipienze. Il mistero dell'eucaristia - che lo mantiene veramente, realmente, corporalmente presente in mezzo a noi - è il segno più convincente della fedeltà del Signore Gesù alla famiglia dei figli di Adamo, che è anche sua.
Egli non è venuto per giudicare e condannare il mondo, ma per salvarlo (cf Gv 12,47). E del Suo "Corpo dato" e del Suo "Sangue versato" ha fatto la sorgente inesauribile di una vitalità nuova che, contro la vecchiezza ripetitiva e monotona delle trasgressioni umane, mantiene desto nella nostra coscienza l'ideale di una convivenza più giusta, più illuminata, più libera, più fraterna.
Sotto i veli conviviali del pane e del vino, la Parola di Dio si è fatta per noi cibo e bevanda; e noi, che di essa ci nutriamo, dobbiamo diventare viventi parole di Dio per i nostri contemporanei.
L'Eucaristia, assimilata nella fede e nell'amore operoso, faccia allora di ciascuno di noi un annuncio di verità, di speranza, di gioia per ogni uomo che incontriamo sul nostro cammino.

[Modificato da Caterina63 21/05/2015 15:45] Fraternamente CaterinaLD
"Siamo mendicanti e chiediamo agli altri anche le loro idee, come la staffetta della posta che riceve il documento dalle mani di uno e poi corre per darlo ad un altro. Faccio una timida parafrasi delle parole di chi ci ha preceduto nel cammino della fede, per annunciarle ad altri."
(fr. Carlos Alfonso Azpiroz Costa OP
Maestro dell’Ordine) |
| | | OFFLINE | Post: 39.988 | Sesso: Femminile | |
|
 21/05/2015 14:38 21/05/2015 14:38 | |
 SALUTO AI GIOVANI CONVENUTI A BOLOGNA SALUTO AI GIOVANI CONVENUTI A BOLOGNA
IN OCCASIONE DELLA
XV GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU'
Domenica 13 agosto 2000 - ore 19,00 - Parco del Seminario
Siete in cammino verso Roma, desiderosi di incontrarvi con l'apostolo Pietro che continua a vivere e a guidare la Chiesa nella persona del suo Successore.
E proprio l'apostolo Pietro qui, a Bologna, ha cominciato a parlarvi. E voi qui, in questo Vespro, già avete cominciato ad ascoltarlo.
Che cosa vi ha detto? Vi ha detto che siete fortunati.
Avete la fortuna di sapere che c'è un Dio che ci ama e ha per noi una "grande misericordia" (l Pt 1,3): una misericordia più grande di ogni nostra debolezza e di ogni nostro peccato. Sapere che c'è un Dio che ci ama, vuol dire sapere che l'universo non è un deserto, che l'umanità non è un enorme orfanatrofio, che noi non siamo i balocchi di un "Caso" anonimo, gelido e cieco.
È un Dio che non è un essere lontano, distaccato, indifferente ai nostri guai. Al contrario, è un Dio che è "padre": è il "Padre del Signore nostro Gesù Cristo" (ib.).
Ed è la seconda fortuna: la conoscenza del Signore Gesù. Noi sappiamo che la creazione non è un'accozzaglia di oggetti dispersi e disparati: ha un "centro" e un "cuore" in Gesù di Nazaret, crocifisso per noi e risorto, oggi vivo come siamo vivi noi; vivo e attento a ciò che diciamo di lui, a ciò che facciamo per lui, a ciò che siamo capaci di donargli.
La terra nelle sue miserie e nelle sue sofferenze non può essere riscattata dalle immagini o dalle parole: ha bisogno di fatti. La storia - questa vicenda ripetitiva di errori e di crudeltà - non può essere redenta da una dottrina o da una ideologia: ha bisogno di avvenimenti.
Ebbene, il "fatto" decisivo è avvenuto, un "avvenimento" unico e imparagonabile ci è stato annunciato: è - ci ha detto san Pietro - 'la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una speranza viva, per una eredità che non si corrompe" (1 Pt 1,3-4).
E questa è la terza fortuna: abbiamo una speranza che non delude e non tramonta mai, a differenza di tutte le attese mondane. Essa - ci è stato detto dal Principe degli Apostoli - "è conservata nei cieli per noi, che dalla potenza di Dio siamo custoditi mediante la fede per la nostra salvezza" (lPt 1,4-5).
Perché di tre cose l'uomo ha un'assoluta necessità, per poter vivere decentemente e ragionevolmente da uomo: di essere certo che il suo esistere abbia un significato e la sua vita non sia una favola senza capo né coda raccontata da un idiota; di vedere sempre davanti a sé una mèta, un traguardo non illusorio, in modo che i nostri passi e le nostre giornate non siano quelli di un viandante pazzo che non sappia dove stia andando né quelli di un pellegrino smemorato che non si ricordi più quale sia la sua destinazione; di aver qualcuno da conoscere e amare, che abbia volto e cuore di uomo ma anche una bellezza divina ed eterna. Vale a dire, qualcuno come il Signore Gesù, il Figlio di Maria che è anche l'Unigenito del Padre, nel quale - come dice l'apostolo Paolo - "abita corporalmente tutta la pienezza della divinità" (Col 2.9).
Tali preziose verità sono già custodite nel vostro animo, e voi andate a Roma per essere confermati in questa fede, in questa speranza, in questa capacità di amare.
Si capisce allora perché san Pietro, nella breve lettura che abbiamo ascoltato, vi suggerisca di esprimere la vostra gioia e la vostra riconoscenza, e vi inviti a dire con lui: "Sia benedetto Dio, il Padre del Signore nostro Gesù Cristo" (1 Pt 1,3).

SALUTO AI PARTECIPANTI AL CONVEGNO:
"L'EUROPA DEL 9 MAGGIO 1950 HA CINQUANT'ANNI"
Sabato 13 maggio 2000 -
Sono lieto di porgere il mio saluto cordiale ai promotori, agli organizzatori, ai relatori e a tutti i partecipanti di questo incontro, posto al servizio e nella prospettiva di una presenza più consapevole e determinante della cultura cattolica nella costruzione della nuova Europa.
Questa giornata, che intende rievocare una data storica della comunità europea - il famoso discorso di Schuman del 9 maggio 1950 - prende le mosse dalla volontà di ricordare anche la figura di una personalità di eccezionale levatura intellettuale e morale, il conte Giovanni Acquaderni, considerato in questo contesto quale uomo europeo per la vastità dei suoi interessi e delle sue relazioni personali.
Dall'Acquaderni si arriva alla figura di Robert Schuman, nel 50mo anniversario del discorso suddetto, da cui si avvia il cammino dell'unità europea.
E a Schuman accostiamo infine - ed è naturale - i grandi nomi di De Gasperi e di Adenauer.
Mi è caro evidenziare che si tratta di tre cattolici, nei quali una fede sentita e vissuta si coniugava con una grande esperienza politica e culturale; fede ed esperienza che si avvertono già nelle premesse, doverosamente 'laiche', del trattato della prima realtà europea, la Ceca, ossia la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio (1951): 'Gli stati membri sono risoluti a sostituire alle rivalità secolari una fusione dei loro interessi essenziali, a fondare una comunità economica, le prime assise di una comunità più vasta e più profonda tra i popoli per lungo tempo avversi per divisioni sanguinose, e a porre fondamenti di istituzioni capaci di indirizzare un destino ormai condiviso'.
I tre fondatori ebbero il merito di capire che l'europeismo poteva nascere solo dalla coscienza di appartenere a una civiltà fondata sui valori cristiani e sui principi di libertà. 
Dal 1950, attraverso una serie di tappe intermedie, si è giunti al traguardo dell'Euro. È innegabile che l'impulso prevalente che ha consentito di raggiungere questa mèta è stata quella degli interessi economici. Anche nel 1950 gli accordi avevano una evidente natura economica, ma erano animati da una tensione morale protesa a rendere più confortevole e giusta la vita di tutti, con una sollecitudine preferenziale alle classi subalterne; tensione che si alimentava alle indicazioni delle Encicliche sociali dei Papi.
Quella ispirazione, purtroppo, sembra essersi estenuata: ha prevalso il calcolo senza uno slancio ideale, in uno scenario dominato dall'alta finanza e dal mercato.
Questa giornata potrà evidenziare - mi auguro - quanta distanza ci separa dal progetto dei padri fondatori dell'unità europea e come sia urgente riprenderne il discorso e le indicazioni.
Un personaggio anglosassone disse che l'Italia non deve venir meno al suo compito di 'custode della memoria': memoria della sua storia così profondamente inserita in quella europea; memoria come ritorno alle sorgenti umanistiche e cristiane; memoria come potenziamento del nostro presente mediante una ricchezza culturale ancora ben sedimentata nella coscienza collettiva.
Sull'esempio dei tre grandi fondatori dell'unità europea i cattolici sono sollecitati a lavorare per un progetto capace di ridare un'anima a una Europa sovrabbondante di agi e di mezzi, ma spiritualmente depressa e inaridita.
L'odierna impressionante povertà morale deve essere vinta con una rigenerazione nutrita ai temi perenni e universali della nostra tradizione.
Insieme coi cattolici, l'Italia tutta è chiamata a ravvivare i suoi miracoli di civiltà per ridonare all'Europa quel sentimento quasi messianico che essa ha sperimentato in altre situazioni, congiunto con una rinnovata attenzione ai valori trascendenti e con un ricupero della classicità senza i quali non è possibile nessun rinnovamento profondo.
Questa consapevolezza di avere una grande missione da compiere ci aiuterà a collocarci nell'Europa unita non come una colonia culturale del mondo anglosassone o come duplicato senza rigore e senza originalità della Francia o della Germania, ma con una precisa identità e con il convincimento di ripresentare, per quel che è possibile, quanto l'Italia seppe compiere ai tempi di San Benedetto, di San Fancesco, di Dante, dell'Umanesimo, del Rinascimento e della Riforma cattolica (amerei anzi dire della 'Riforma borromaica').
L'impresa è alta e difficile. Ma, come sta scritto, 'questa è la vittoria che ha sconfitto il mondo: la nostra fede' (cf. 1Gv 5,4).
Sono grato agli ideatori e agli artefici del Convegno, mentre a tutti auguro un buon lavoro.

Fraternamente CaterinaLD
"Siamo mendicanti e chiediamo agli altri anche le loro idee, come la staffetta della posta che riceve il documento dalle mani di uno e poi corre per darlo ad un altro. Faccio una timida parafrasi delle parole di chi ci ha preceduto nel cammino della fede, per annunciarle ad altri."
(fr. Carlos Alfonso Azpiroz Costa OP
Maestro dell’Ordine) |
| | | OFFLINE | Post: 39.988 | Sesso: Femminile | |
|
 21/05/2015 14:59 21/05/2015 14:59 | |
 CONFERENZA SUL TEMA CONFERENZA SUL TEMA
"IL MISTERO DELLA ZIZZANIA"
Giovedì 4 maggio 2000 - ore 17,30 - Palazzo del Baraccano
Vorrei proporre di riflettere su una famosa parabola del Signore, che ci è riferita soltanto dal vangelo di Matteo. Dopo la lettura e qualche osservazione generale, la esamineremo su tre livelli interpretativi: cosmico, ecclesiale, antropologico, per concludere con qualche annotazione d'indole pastorale.
A) La parabola di Gesù
Il testo evangelico
"Il Regno dei cieli si può paragonare a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma mentre tutti dormivano venne il suo nemico, seminò zizzania in mezzo al grano e se andò. Quando poi la messe fiorì e fece frutto, ecco apparve anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: "Padrone, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene dunque la zizzania?" Ed egli rispose loro: Un nemico ha fatto questo. E i servi gli dissero: Vuoi dunque che andiamo a raccoglierla? No, rispose, perché non succeda che, cogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l'una e l'altro crescano insieme fino alla mietitura e al momento della mietitura dirò ai mietitori: Cogliete prima la zizzania e legatela in fastelli per bruciarla: il grano invece riponetelo nel mio granaio " (Mt 13,24-30).
"Poi Gesù lasciò la folla ed entrò in casa; i suoi discepoli gli si accostarono per dirgli: Spiegaci la parabola della zizzania nel campo. Ed egli rispose: "Colui che semina il buon seme è il Figlio dell'uomo. Il campo è il mondo. Il seme buono sono i figli del regno; la zizzania sono i figli del maligno, e il nemico che l'ha seminata e il diavolo. La mietitura rappresenta la fine del mondo, e i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e si brucia nel fuoco, così avverrà alla fine del mondo. Il Figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti gli operatori di iniquità e li getteranno nella fornace ardente dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del padre loro. Chi ha orecchi intenda! " (Mt 13,36-43).
II
Osservazioni previe e generali
1. "Da dove viene la zizzania?" (Mt 13,27). Da dove è venuta questa erbaccia maligna e soffocatrice che infesta il campo di Dio?
È una delle domande più serie e decisive, e siamo tutti costretti a formularla quando ci poniamo di fronte al mistero dell'esistenza: o neghiamo l'evidenza del male (ed è un impresa disperata) o ci interroghiamo circa la sua provenienza .
2. Sulle labbra dei contadini della parabola l'interpellanza sembra esprimere non solo stupore, ma anche delusione e quasi una specie di rabbia. Sembra anzi marcata da un accento di velato rimprovero verso il padrone, che in fin dei conti è il primo responsabile della coltivazione: "Non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove dunque viene la zizzania?".
Dobbiamo dire però che quei contadini almeno una fortuna ce l'hanno, ed è di avere un padrone con cui lamentarsi: è già una consolazione prendersela con qualcuno. A chi ritenesse che il campo non sia di nessuno e ogni accadimento sia in esso del tutto casuale, non sarebbe consentito neppure di protestare o di fare domande, per assenza di destinatari responsabili.
Se non esiste un proprietario del campo con un suo programma operativo, se tutto nell'universo è fortuito, allora, pur avvertendo ancora i morsi del male, non siamo più autorizzati né a lagnarci né a enunciare problemi, perché in quel caso non si dà spazio per nessuna verità e quindi per nessuna ricerca. Dove si prende per buona l'ipotesi del caso, non può sorgere alcuna plausibile investigazione.
Deve essere tremenda la condizione degli atei, e proprio per questo: per il fatto di non poter riconoscere di fronte a sé nessun interlocutore adeguato. Un ateo vero e coerente è in realtà il più sfortunato degli uomini perché, messo di fronte ai guai inevitabili dell'esistenza, si priva perfino della soddisfazione di protestare con qualcuno e di bestemmiare.
Mi torna alla mente ciò che diceva C.S. Lewis (l'autore delle famose Lettere di Berlicche), ricordando il tempo della sua incredulità: "Negavo l'esistenza di Dio ed ero arrabbiato con lui perché non esisteva".
Personalmente devo confessare che, a essere sincero, io non posso fare a meno di un interlocutore trascendente. Certo, posso parlare anche con gli uomini, quando si tratta di questioni come la politica italiana o l'inflazione o il campionato dl calcio. Ma degli argomenti che davvero contano - come è appunto quello del bene e del male, e dell'enigmatica origine del male - con chi volete che ne possa trattare, se mi manca un Dio con cui entrare in dialogo?
Con chi volete che esamini il problema del senso ultimo della vita? Mica lo posso fare con l'on.Pannella. Con chi volete che affronti il tema del mio destino eterno? Mica ne posso chiedere conto a Vittorio Sgarbi. Per citare solo alcuni tra i "direttori spirituali" più noti del nostro tempo
Di queste cose - e sono le sole che veramente mi interessano - o sono costretto a tacere (censurandone in me irragionevolmente persino il pensiero) o ne devo discutere (e in realtà mi capita di farlo ogni giorno) unicamente con Dio.
A lui posso rivolgermi con le parole di Geremia:
"Tu sei troppo giusto, Signore,
perché io possa discutere con te;
eppure ti voglio rivolgere ugualmente
una parola sulla giustizia" (Ger 12,1).
Anche a me, come a Giobbe è dato di proporgli:
"Io ti interrogherò e tu istruiscimi" (Gb 42,4).
E se mi parrà di aver di fronte, come un muro, il silenzio di Dio, anch'io come il profeta Abacuc vigilerò davanti a questo muro:
"Mi metterò di sentinella"
a spiare, per vedere che cosa mi dirà,
che cosa risponderà ai miei lamenti" (Ab 2,1).
Per la verità, il muro è già stato squarciato dalla divina Rivelazione. Abbiamo già avuto una risposta, e proprio da questa parabola di Gesù: si tratta solo di capirla bene e di lasciarci illuminare dalla sua luce.
3. Se il padrone del campo fosse stato un tipo irenico e postconciliare, si sarebbe rifugiato in una qualche rassicurante congettura naturalistica o accidentale. Alla domanda: "Da dove viene la zizzania?", avrebbe probabilmente risposto: "Sapete com'è, le erbacce spuntano da sole, ci sono un po' dappertutto, non bisogna farne un dramma; c'è il vento, ci sono gli uccellini che abbandonano nei solchi ogni sorta di seme imprevisto, è una cosa normale, anzi è un fatto ecologico".
Invece quel padrone non ha esitazioni nell'assegnare al guaio che gli viene denunciato una causa personale, subdola e malevolente: "Un nemico ha fatto questo" (Mt 13,28), e il narratore della parabola ci conferma che la deduzione del padrone è ineccepibile. Le cose sono davvero andate così: "Mentre tutti dormivano venne il suo nemico, seminò zizzania in mezzo al grano e se ne andò" (Mt 13,25).
Questo nemico, che opera nella notte i suoi malefizi e poi scompare, riesce a far perdere così bene le sue tracce, che molti anche tra i servi stipendiati dell'azienda agricola non tengono conto più della sua esistenza. Qualcuno non prende più sul serio nemmeno l'esistenza della zizzania; qualche altro dà l'impressione che non creda più addirittura all'esistenza del campo. Questo nemico riesce a ingannare tutti; tutti, tranne il padrone.
Sarà meglio allora che ricominciamo a fare più attenzione al parere del divino Agricoltore (cfr Gv 15,1), se vogliamo che la nostra indagine sul grano e sulla zizzania non sia vanificata in partenza.
B) Triplice livello interpretativo
I
Interpretazione "cosmica"
L'interpretazione cosmica è offerta direttamente ed esplicitamente da Cristo stesso quando dice: "Il campo è il mondo" (Mt 13,38).Secondo questa lettura, la parabola evangelica è un invito a riflettere sul male e la sua origine nell'universo.
L'insegnamento di Gesù a questo proposito è estremamente sintetico ma limpidissimo: il nemico che ha frammischiato l'erbaccia alla buona coltivazione di Dio è il diavolo (Mt 13, 39).
Mette conto che abbiamo a richiamare, sia pure in cenni rapidissimi, l'intera concezione della fede cattolica circa il male del mondo (concezione che è implicitamente evocata da questa breve frase del Signore). Essa oggi è così faziosamente e acriticamente contrastata dalla cultura dominante, che càpita di percepire una irritata meraviglia - quando non addirittura di sentir gridare allo scandalo - se il papa o qualche vescovo la ripropone nella sua semplicità e nella sua nativa interezza. Come se fosse impensabile, dopo tutte le aperture e gli irenismi, che ci sia ancora qualche cristiano che si attardi a pensare da cristiano.
Secondo il realismo della Rivelazione, il male - inteso senza ambiguità come colpevole prevaricazione morale - esiste. "Voi che siete cattivi" (Mt 7,11), dice tranquillamente Gesù ai suoi ascoltatori; e così ci ammonisce che non ci si deve fare illusioni di tipo illuministico sulla nativa bontà morale dell'uomo.
Le illusioni, tra l'altro, si sono rivelate storicamente molto pericolose. L'ottimismo naturalistico del secolo XVIII (che si contrapponeva, irridendoli, ai dati della fede) di fatto negli ultimi anni di quel secolo è approdato all'omicidio perpetrato, per così dire, su scala industriale, con indici inauditi di produzione resi possibili dalla geniale invenzione della ghigliottina. Le ideologie che si rifiutavano di credere alla malvagità del cuore dell'uomo, hanno dato vita ripetutamente in questi due secoli a forme esasperate di crudeltà.
L'iniquità umana c'è, ed è largamente diffusa. Così diffusa da costituire un problema: come mai gli uomini più o meno tutti sconfinano nell'ingiustizia? La Rivelazione cristiana risponde con la dottrina del peccato originale.
La verità del peccato originale come ogni mistero è oscura in se stessa, ma è illuminante per noi e per la nostra condizione. Indubbiamente si fatica a capirla nella sua natura e nelle sue cause; ma senza di essa tutto nel mondo e nell'uomo si fa ancora più impenetrabile, a cominciare dal mare di lacrime e di sangue che ricopre la nostra storia.
San Paolo nella lettera ai Romani richiama vigorosamente questo generale deterioramento, instauratosi all'alba dell'umanità, e ne fa la necessaria premessa per comprendere in tutta la sua valenza l'opera redentrice di Cristo: "Come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e con il peccato la morte, così anche la morte ha raggiunto tutti gli uomini sicché tutti hanno peccato... Come dunque per la colpa di uno solo si è riversata su tutti gli uomini la condanna, così anche per l'opera di giustizia di uno solo si riversa su tutti gli uomini la giustificazione che dà vita. Similmente, come per la disobbedienza di uno solo tutti sono stati costituiti peccatori, così anche per l'obbedienza di uno solo tutti saranno costituiti giusti" (Rm 5,12.18-19).
A dire il vero, il libro della Genesi, raccontando la colpa di Adamo e di Eva come frutto della istigazione perfida del serpente, sembra insinuare che l'inizio assoluto del male nell'universo vada ricercato antecedentemente alla comparsa dell'uomo sulla terra. E il libro della Sapienza - implicitamente citato da san Paolo nella lettera ai Romani - dà una lettura teologica dell'antico racconto indicando nel demonio la prima fonte delle nostre sciagure: "La morte è entrata nel mondo per invidia del diavolo; e ne fanno esperienza coloro che gli appartengono" (Sap 2,24).
Ci ritroviamo così all'identico insegnamento offertoci da Gesù appunto nella parabola che stiamo tentando di capire: "Il nemico che ha seminato la zizzania è il diavolo" (Mt 13,39).
Come si vede, la nostra meditazione sul male del mondo è stata progressivamente sospinta dalla verità del peccato personale a quella del peccato che dall'alba della vicenda umana universalmente contamina la nostra stirpe; e dalla verità del peccato originale a quella dell'esistenza del demonio, prima e oscura fonte di ogni perversione.
Siamo così invitati a risalire a poco a poco l'enigmaticità delle cose fino a raggiungere la soglia del mondo invisibile che precede la storia dell'uomo; vale a dire la soglia della realtà che sta al di fuori e al di sopra del nostro tempo.
I guai di cui ci sforziamo di renderci conto hanno, come si vede, radici lunghissime e premesse extratemporali. Léon Bloy ha una piccola frase splendente di verità: "Il male di questo mondo è di origine angelica e perciò non può essere espresso in lingua umana" (Le sang du pauvre, Conclusion). 
Nella cristianità contemporanea è in atto invece un curioso processo di smarrimento, tanto che si arriva a percorrere in senso contrario la strada sulla quale, come s'è visto, siamo stati guidati dalla fede.
Tra i teologi c'è chi si impegna alacremente in un lavoro cosiddetto di smitizzazione, dopo il quale del demonio non resta neppure la coda. Questi teologi - diversamente da Gesù Cristo - pare che non pensino più a satana come a un essere reale concretamente e personalmente esistente; sembrano piuttosto ridurlo a una sorta di immagine simbolica della intrinseca inclinazione al male che c è nelle creature.
Ma - tolto di mezzo il diavolo - anche il peccato originale non è più plausibile; e infatti in molte odierne presentazioni teologiche esso fatalmente si estenua e si sbiadisce fino a essere la cifra dell'umana finitezza o al più la denominazione collettiva di tutte le colpe individuali. Le quali, a loro volta, tendono a essere considerate non tanto come peccati responsabilmente commessi quanto come turbe psichiche conseguenti a squilibri congeniti o alla violazione di tabù senza fondamento.
Insomma, prima si risolve l'idea del demonio in quella del peccato originale, poi l'idea del peccato originale in quella dei peccati dei singoli, infine l'idea dei peccati dei singoli in quella di un malessere senza colpevolezza. Così l'universo diventa una specie di innocente giardino d'infanzia, senza malvagità e senza malvagi, dove però non si capisce più perché tanto spesso ci si imbatta nella ferocia umana, e soprattutto non si capisce più che senso abbiano la morte, il dolore, la redenzione di Cristo.
Un mondo così sarà anche bello, ma ha l'inconveniente di non esistere affatto.
Verso la miseria umana questa è, a ben guardare, una falsa pietà, che ritiene di liberarci dal male negandolo e aiutandoci a non credere più nel demonio, a vanificare la dottrina della colpa d'origine, a banalizzare l'idea stessa di responsabilità personale.
La vera misericordia - quella di Dio - batte la strada opposta.
Il grande avversario comincia a essere sconfitto non nel momento in cui lo si relega tra le favole ma nel momento in cui lo si prende sul serio, in modo da prendere sul serio la vittoria ottenuta su di lui dalla morte e dalla risurrezione del Figlio di Dio; vittoria che quotidianamente si impianta nella vicenda di ognuno di noi mediante la nostra crescente partecipazione al mistero pasquale.
L'universale decadenza della natura umana può essere superata solo partendo dalla persuasione che Dio ha rinchiuso tutti nella disobbedienza, per usare a tutti misericordia (cfr Rm 11,32).
E dal mio peccato personale incomincio con la grazia divina a risorgere non nel momento in cui lo ignoro o lo censuro psicologicamente, ma nel momento in cui, pentendomi, lo riconosco come atto veramente cattivo e veramente mio.
Questo è il senso della proposta evangelica della "metànoia" (della conversione), che Gesù ci ha indicato come necessaria premessa della nostra salvezza. Il Vangelo non è la notizia che siamo già tutti innocenti per incapacità di intendere e di volere o perché i fatti non costituiscono reato; è la notizia che siamo tutti peccatori e, proprio per questo, siamo i fortunati destinatari dell'invincibile misericordia del Padre.
II
Interpretazione ecclesiologica
La parabola può legittimamente essere posta al servizio di una giusta visione ecclesiologica, contro la tentazione di concepire la comunità cristiana come una aggregazione di soli santi, dalla quale perciò sarebbero da ritenere esclusi quanti vivono nella incoerenza e nel peccato.
Come tutte le vere tentazioni, anche questa possiede innegabilmente un suo fascino, e non ci meraviglia che si sia ripetutamente presentata nella cristianità a partire dai primi secoli, e che riaffiori ogni tanto qua e là anche ai nostri giorni. Possiamo anzi dire che non c è appassionato dibattito pastorale in cui presto o tardi, in forma più blanda o più radicale, qualcuno non arrivi a domandarsi se non sia il caso di inseguire con maggior severità l'ideale di una Chiesa composta solo di gente che viva davvero secondo il progetto esistenziale di Cristo; di una Chiesa dunque capace di estromettere dal suo seno coloro che nell'itinerario evangelico non tengono perfettamente il suo passo.
La Chiesa però - pur conservando l'istituto della scomunica secondo le istruzioni ricevute dal suo Signore (cfr Mt 18,15 -18), per i casi più gravi e sempre con intento dichiaratamente medicinale - non ha mai pensato a se stessa come a un'accolta di soli giusti. Anzi, secondo lo spirito del Messia, è sempre stata riluttante a spegnere il lucignolo fumigante e a spezzare del tutto la canna incrinata (cfr Is 42, 3).
"Lasciate che il frumento e la zizzania crescano insieme" (cfr Mt 13,30), dice sorprendentemente il padrone ai servi, che invece avevano già dal canto loro optato per la linea della chiarificazione, cioè della durezza e della scelta immediata.
Quei dipendenti avranno certamente mugugnato tra loro: "Che razza di padrone! Non si rende conto di com'è difficile che in queste condizioni il grano possa crescere bene? Non si accorge che con un campo così - con una Chiesa così - fa una brutta figura anche lui agli occhi di tutti? Non riesce a prevedere le sofferenze che sta per infliggere sia alla graminacea buona sia a quella cattiva con una coabitazione così eterogenea e reciprocamente fastidiosa"?.
Ma il padrone è irremovibile: "Lasciate che crescano insieme".
Non è difficile supporre le ragioni - tutte di misericordia - che soggiacciono a questa decisione divina,
Di là dall' immagine, qui si tratta di uomini, che si comportano di volta in volta da figli del Regno e da figli del Maligno (cfr Mt 13,38). E per gli uomini come tali si può sempre evangelicamente sperare, prima che con la morte i giochi si chiudano, nel totale ravvedimento; ravvedimento che va in tutti i modi facilitato, non reso più arduo.
E poi, chi di noi può dire di essere compiutamente coerente con la propria fede? Se l'incoerenza - sia pur grave - estromettesse dalla Chiesa, chi di noi potrebbe presumere del suo buon diritto di farvi parte? E infine, se ci abbandonassimo ad accusarci a vicenda, con criteri che spesso sono opinabili e cangianti, di indegnità ecclesiale - singoli contro singoli, gruppi contro gruppi, movimenti contro movimenti - che cosa resterebbe alla fine del popolo di Dio?
Il Signore vuole appassionatamente che la sua Chiesa viva in forma sempre più estesa e profonda la sua vita di "sposa" e di "corpo" di Cristo, e perciò desidera che non si stanchi di proporre a tutti i suoi membri in modo forte ed efficace il traguardo della perfezione evangelica. Ma sa altresì che essa, finché camminerà sulle strade polverose della storia, sarà sempre una comunione santa di uomini peccatori, e di deboli che cercano senza scoraggiarsi di vivere da figli di Dio, di agire da creature rinnovate, di comportarsi da fratelli in Cristo, pur nella consapevolezza di non riuscirci mai in misura adeguata e soddisfacente.
Il costruttore della celeste Gerusalemme è esigente, e ha disposto fin d'ora che non entrerà in essa nulla di impuro (cf Ap 21,27). Ma solo alla fine dei secoli la discriminazione piena e definitiva sarà fatta: "Come si raccoglie la zizzania e si brucia nel fuoco, così avverrà alla fine del mondo. Il Figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti gli operatori di iniquità e li getteranno nella fornace ardente dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti risplenderanno come il sole nel regno del Padre loro" (Mt 13,40-43).
A prevenire ogni equivoco, sarà bene ricordare che la tolleranza vicendevole, indispensabile tra cristiani sempre imperfetti e sempre un po' incoerenti, non significa affatto attenuazione nell'impegno a combattere l'errore né ambiguità nella condanna del male.
La coesistenza del grano e della zizzania nello stesso campo di Dio vuol dire che dobbiamo avere molta pazienza con la concretezza dei casi umani. Lo stile cristiano rifugge dagli attacchi personali, ma questo non significa che dobbiamo rassegnarci a trattare con la stessa benevolenza la luce e le tenebre, né che si debba dare la stessa cittadinanza nella Chiesa, magari con la scusa del dialogo, alla verità rivelata e all'eresia, né che si possa mantenere un'amabile neutralità nella guerra tra le "porte degli inferi" e la Chiesa di Cristo (cfr Mt 16,18). 
Chi vuol vivere in pienezza la vita ecclesiale, è chiamato ogni giorno a lottare con lucidità e con energia, senza lasciarsi incantare dai programmi di cedimento e di resa, che di questi tempi sembrano configurare nella cristianità una smobilitazione generale dei credenti, con pochi precedenti nella storia. Ma anche senza mai pretendere che nella compagine ecclesiale restino soltanto coloro che sono perfettamente adeguati ai modelli assoluti di perfezione o, peggio ancora, agli schemi di vita ecclesiale che un singolo o un gruppo ha percepito come vincolanti.
III
Interpretazione antropologica
La lettura antropologica - che si propone di riferire la figura del campo al mondo interiore dell'uomo - è giustificata non tanto dalla narrazione della parabola in se stessa quanto da un'immagine che ripetutamente ritorna nella rivelazione. Essa perciò potrà avvalersi solo di quegli elementi del racconto evangelico che convengono a questa particolare tematica.
Già Isaia aveva parlato di Israele come della vigna amorosamente coltivata dal Signore (cfr Is 5,1ss), la sua piantagione preferita (Is 5,7), che però ha deluso il suo agricoltore producendo uva immangiabile (cfr Is 5,2).
L'esortazione a produrre buoni frutti, che appaghino il Coltivatore, ritorna sulle labbra di Gesù nei discorsi giovannei dell'ultima cena: "In questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto" (Gv 15,8); "io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto" (Gv 15,16).
Di questi frutti, che ciascuno di noi deve maturare per il suo Dio, san Paolo fornisce qualche elenco significativo: "Il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità" (Ef 5,9); "il frutto dello spirito è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé" (Gal 5,22).
Tutta questa spirituale fecondità è possibile perché è instancabile l'Agricoltore divino che si prende cura di noi.
"Voi siete il campo di Dio" (1 Cor 3,9), è la sintetica e illuminante conclusione di Paolo.
Del resto, sempre nel capitolo 13 di Matteo, immediatamente prima della parabola della zizzania, il Signore, spiegando la parabola del seminatore, nel terreno aveva visto rappresentato appunto il cuore dell'uomo (cfr Mt 13,19), dove il seme della parola di Dio può incontrare a seconda dei casi una sorte ben diversa e avere una ben diversa fertilità,
Una volta identificato il "campo" della parabola col nostro mondo interiore, alcuni spunti di riflessione si impongono immediatamente.
In primo luogo nasce in noi un vivissimo sentimento di speranza e di serenità. Noi, come dicevamo, siamo il campo di Dio : il divino Coltivatore è sempre all'opera su di noi, sicché, anche dopo ogni deludente raccolto, possiamo sempre confidare in un avvenire fruttuoso. Non può rimanere del tutto infecondo un terreno che è sottoposto alle cure sapienti e perseveranti del Signore.
In secondo luogo, è chiaro che quanto di buono è prodotto nella nostra esistenza si deve all'eccelsa qualità del seme di cui siamo stati arricchiti: "Che cosa possiedi che tu non abbia ricevuto? E se l'hai ricevuto, perché te ne vanti come non l'avessi ricevuto?" (1 Cor 4,7).
Ma l'approfondimento più prezioso ci è dato dalla scoperta che - quale che sia il grado di santità a cui si è arrivati - nel nostro mondo interiore il cattivo loglio, poco o tanto, si mescola sempre al buon grano. Il demonio, che pure è già stato sostanzialmente sconfitto da Cristo, esercita ancora - e la eserciterà sino alla fine della storia - la sua triste prerogativa di tentatore, e continua a profondere nella nostra anima i suoi germi malvagi.
Il nostro cuore - dobbiamo persuadercene - è dunque perennemente afflitto dalle molte erbacce di male, che mirano a soffocare in noi la coltivazione di Dio.
Se non siamo troppo superficiali o vanesi, facciamo l'esperienza quotidiana della nostra molteplice perversità, ed è una rivelazione che ci incute spavento. In una famosa battuta, amara ma ricca di universale verità, Amleto dice impietosamente di sé: "Io sono più o meno onesto, eppure potrei accusarmi di tali cose, che meglio sarebbe se mia madre non mi avesse messo al mondo. Io sono orgoglioso, vendicativo, ambizioso, posso con un solo tratto evocare più peccati che non abbia pensieri per meditarli, immaginazione per dare loro forma o tempo per compierli. A che giova che esseri come me striscino fra la terra e il cielo?" (Shakespeare, Amleto III,1).
Dopo una introspezione molto simile a questa, san Paolo nella lettera ai Romani conclude con un grido di angoscia: "Sono uno sventurato! Chi mi libererà da questo corpo votato alla morte?" (Rm 7,24).Ma risponde subito al drammatico interrogativo con una esplosione di riconoscenza per la liberazione che ci è stata donata: "Siano rese grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore" (Rm 7,25).
Chi mantiene acuta la consapevolezza di questo suo stato interiore di propensione al male - che può però essere sempre vittoriosamente contrastato dalla grazia di Dio - vive in un atteggiamento di profonda umiltà; ed è un'umiltà che naturalmente si traduce in un attitudine di dolcezza e di indulgenza verso gli altri: la coscienza dei nostri limiti e dei nostri errori ci fa passare la voglia di farci critici aspri dei limiti e degli errori altrui.
È ovvio che per questa interpretazione antropologica non varrà l'invito a lasciare che la zizzania cresca indisturbata insieme col buon frumento. Al contrario, vedremo come si imponga un lavoro assiduo di ripulitura del nostro campo interiore: ogni giorno riconosceremo che dentro di noi il loglio è ripullulato, e ogni giorno dovremo darci da fare a estirparlo. 
Qui si profila per il cristiano l'evidente rilevanza di un robusto e tenace impegno ascetico. Chi si appagasse dell'annuncio inebriante della liberazione e della nuova realtà esistenziale regalataci da Cristo, e non attendesse contestualmente all'opera di purificazione dei propri pensieri, del proprio linguaggio, delle proprie tendenze, delle proprie abitudini di vita, rischia di ingannare se stesso e di illudersi pericolosamente.
Dalla parabola possiamo però raccogliere l'invito ad avere pazienza anche con noi stessi e coi nostri difetti sempre rinascenti.
Il Padrone - che nel racconto esorta i servi alla calma e all'attesa - esorta anche noi a non lasciarci prendere, nei nostri tentativi di combattere le continue rinascenze del male, da una insofferenza che poi potrebbe concludersi con lo sconforto e la resa.
Abbiamo un buon Padrone, che cura il suo campo con amore forte e tranquillo. Noi però siamo chiamati a lavorare con lui, in modo che il terreno risulti il più possibile mondo e ubertoso. Noi - ci dice ancora san Paolo - "siamo collaboratori di Dio" (cfr 1 Cor 3,9); cioè dobbiamo dargli sul serio una mano nell'opera della nostra salvezza e della nostra interiore coltivazione.
C) Osservazioni conclusive
Non ci rimane ormai che indicare alcuni pochi propositi pratici quasi a frutto di questa inconsueta meditazione.
1. Non ci lasceremo incantare né dalle vecchie ideologie né dai "nuovi messaggi", che si offrono a noi vantandosi di avere i programmi infallibili per eliminare radicalmente il mondo dal male.
Il male ha la sua vera scaturigine dal cuore dell'uomo, e per estirparlo non basterà mai né il cambiamento delle strutture né il facile ottimismo di prospettive puramente naturalistiche.
"Dal di dentro, cioè dal cuore degli uomini - ha detto Gesù - escono le intenzioni cattive: fornicazioni, furti, omicidi, adultèri, cupidigie, malvagità, inganno, impudicizia, invidia, calunnia, superbia, stoltezza" (Mc 7,21-22).
Ci si può e ci si deve anche adoperare ad avere forme più giuste e più efficienti di aggregazione sociale; ma il reale miglioramento del mondo passa soprattutto attraverso la strada difficile e lunga della conversione dei cuori.
E poiché nei cuori umani il male, come s'è visto, è suscitato in ultima analisi dall'opera di potenze oscure e sovrumane, com'è quella del demonio, i nostri soli mezzi non servono a debellarlo.
"La nostra battaglia infatti - dice san Paolo - non è contro creature di sangue e di carne - <cioè, diciamo noi, non è contro gli squilibri psicosomatici o gli ostacoli di tipo politico-sociale> - ma contro i Principati e le Potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebra, contro gli spiriti del male" (Ef 6, 12). Perciò noi non possiamo sperare di vincere da soli, ma dobbiamo combattere sempre unitamente al Figlio di Dio, il quale proprio per questo "è apparso, per distruggere le opere del demonio" (1 Gv 3,8).
2. Poiché il Signore accoglie e mantiene nella sua Chiesa anche coloro che a noi sembrano cattivi cristiani, e poiché noi stessi probabilmente non siamo ai suoi occhi cristiani del tutto buoni, dobbiamo vivere la nostra vita ecclesiale senza intolleranze e senza durezze verso i nostri i fratelli nella fede (cfr Gal 6,10)
"Non giudicate per non essere giudicati" (Mt 7,1): è uno dei comandi più chiari e vincolanti del Signore Gesù. "Gareggiate nello stimarvi a vicenda" (Rm 12,10), è l'esortazione che san Paolo rivolge alle sue comunità, e quindi anche a noi. E san Giacomo ci mette in guardia contro lo zelo amaro e lo spirito di contesa, che talvolta guasta, credendo di realizzarlo, anche un amore sincero per la verità e per la Chiesa (cfr Gc 3,14).
È bello a questo proposito ricordare l'esempio di san Francesco, il quale non ha mai fatto del suo ideale evangelico di vita ragione di rimprovero per chi si comportava in maniera ben diversa da lui né causa di divisione e di accuse all'interno della cristianità. Scrive al riguardo una delle più antiche biografie: "Insisteva perché i fratelli non giudicassero nessuno, e non guardassero con disprezzo quelli che vivono nel lusso e vestono con ricercatezza esagerata e fasto, poiché Dio è Signore nostro e loro, e ha potere di chiamarli a sé e di renderli giusti. Prescriveva anzi che riverissero costoro come fratelli e padroni".
3. Il terzo proposito riguarda la nostra continua rettificazione interiore, perché il male del mondo si combatte prima di tutto nel cuore.
Lo esprimiamo con le parole di san Paolo ai Colossesi con le quali vorrei concludere questa meditazione: "Mortificate quella parte di voi che appartiene alla terra. Deponete anche voi tutte queste cose: ira, passione, malizia, maldicenze e parole oscene dalla vostra bocca. Non mentitevi gli uni gli altri...Rivestitevi, come amati di Dio, santi e diletti, di sentimenti di misericordia, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza; sopportandovi a vicenda e perdonandovi scambievolmente, se qualcuno abbia di che lamentarsi nei riguardi degli altri. Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi" (Col 3,5.8-9.12-13).
 [Modificato da Caterina63 21/05/2015 15:46] Fraternamente CaterinaLD
"Siamo mendicanti e chiediamo agli altri anche le loro idee, come la staffetta della posta che riceve il documento dalle mani di uno e poi corre per darlo ad un altro. Faccio una timida parafrasi delle parole di chi ci ha preceduto nel cammino della fede, per annunciarle ad altri."
(fr. Carlos Alfonso Azpiroz Costa OP
Maestro dell’Ordine) |
| | | OFFLINE | Post: 39.988 | Sesso: Femminile | |
|
 11/07/2015 18:19 11/07/2015 18:19 | |
Cardinale Biffi: “Col ‘dialogo’ ad ogni costo i cattolici stanno preparando la propria estinzione”

“Dobbiamo salvare l’identità della Nazione dall’annichilimento dei più alti valori della nostra civiltà (…)
Io non ho nessuna paura dell’Islam, ho paura della straordinaria imprevidenza dei responsabili della nostra vita pubblica. Ho paura dell’inconsistenza dei nostri opinionisti. (…)
Sorprendente che gli opinionisti laici non si accorgano di questi pericoli. (…)
Ho paura soprattutto dell’insipienza di molti cattolici. (…)
I cristiani devono piantarla di dire che bisogna andare d’accordo con tutte le idee. (…)
Il mio compito è di evangelizzare i musulmani. È un gravissimo errore rinunciare all’evangelizzazione. (…)
“Oggi è in atto una delle più gravi e ampie aggressioni al cristianesimo che la storia ricordi. Tutta l’eredità del Vangelo viene progressivamente ripudiata dalle legislazioni, irrisa dai ‘signori dell’opinione’, scalzata dalle coscienze specialmente giovanili. Di tale ostilità, a volta violenta a volte subdola, non abbiamo ragione di stupirci né di aver troppa paura, dal momento che il Signore ce l’ha ripetutamente preannunciato: ‘Non meravigliatevi se il mondo vi odia’. Ci si può meravigliare invece degli uomini di Chiesa che non sanno o vogliono prenderne atto. (…)
“L’Europa o ridiventerà cristiana o diventerà musulmana. Ciò che mi pare senza avvenire è la ‘cultura del niente’, della libertà senza limiti e senza contenuti, dello scetticismo vantato come conquista intellettuale.
“Questa cultura del niente non sarà in grado di reggere all’assalto ideologico dell’Islam, che non mancherà. Solo la riscoperta dell’avvenimento cristiano come unica salvezza per l’uomo – e quindi solo una decisa risurrezione dell’antica anima dell’Europa – potrà offrire un esito diverso a questo inevitabile confronto.
“Purtroppo né i ‘laici’ né i ‘cattolici’ pare si siano resi conto del dramma che si sta profilando. I ‘laici’, osteggiando in tutti i modi la Chiesa, non si accorgono di combattere l’ispiratrice più forte e la difesa più valida della civiltà occidentale e dei suoi valori di razionalità. I ‘cattolici’, lasciando sbiadire in se stessi la consapevolezza della verità posseduta, e sostituendo all’ansia apostolica il puro e semplice ‘dialogo’ ad ogni costo, inconsciamente preparano la propria estinzione”.
(Giacomo card. Biffi, Lettera pastorale “La città di S. Petronio nel terzo millennio”, ottobre 2000)

Ricordiamo il card. Giacomo Biffi con uno dei suoi scritti
“Vidi salire dal mare una bestia” (Ap 13,1)
L’ottimismo è di rigore.
Una delle mode culturali più curiose invalse nella cristianità in questi decenni interdice a chi si accinge a stilare un documento o proporre una riflessione sulla odierna condizione umana e sui tempi presenti di iniziare dai rilievi “negativi”: è d’obbligo partire da una rassegna dei dati improntata a un robusto ottimismo; bisogna sempre collocare in capo a tutto un esame della realtà che non tralasci di mettere in giusta luce i valori, la sostanziale santità, la “positività prevalente”.
Qualche volta mi sorprendo a immaginare, per mio personale divertimento, come sarebbe stata la lettera ai Romani se, invece che da quell’uomo difficile e sdegnoso che era l’apostolo Paolo, fosse stata stesa da qualche commissione ecclesiale o da qualche gruppo di lavoro dei nostri giorni.
L’epistola avrebbe cominciato a notare nel primo capitolo col dovuto risalto tutte le ricchezze spirituali e culturali espresse dal mondo pagano: le altezze sublimi raggiunte dalla filosofia greca; la sete del trascendente e il naturale senso religioso rivelati dalla molteplicità dei culti mediterranei; gli esempi di onestà morale, di correttezza civica, di abnegazione disinteressata, offerte dalle vicende edificanti della storia romana che una volta si insegnavano al ginnasio. Senza dubbio se la litanìa immisericorde dei vizi e delle aberrazioni mondane contenuta nell’attuale pagina ispirata, fosse suggerita oggi come contributo al testo da qualche incauto collaboratore, susciterebbe una concorde indignazione. E in realtà il giudizio di Paolo suona alle nostre orecchie insopportabilmente sgradevole: per lui gli uomini senza Cristo sono “colmi di ogni sorta di ingiustizia, di malvagità, di cupidigia, di malizia; diffamatori, maldicenti, nemici di Dio, oltraggiosi, superbi, fanfaroni, ingegnosi nel male, ribelli ai genitori, insensati, sleali, senza cuore, senza misericordia” (Rm 1,29-31).
Messi in bella evidenza i pregi del paganesimo, la nuova lettera ai Romani passerebbe poi a esaltare le prerogative dell’ebraismo e la funzione già incoattivamente salvifica della Legge mosaica, della circoncisione, delle prescrizioni rituali.Infine, arrivata al capitolo quinto, chiarirebbe che l’opera di Adamo non è stata poi così nefasta come una volta si diceva, dal momento che la creazione resta in se stessa buona; anzi in quanto è uscita dalle mani di Dio non può non essere già santa e sacra, senza che siano necessarie altre sopravvenienti consacrazioni.
Certo, a questo punto il discorso su Gesù Cristo, la sua redenzione, il suo intervento indispensabile per il riscatto dell’umanità dall’ingiustizia, dal peccato, dalla morte, dalla catastrofe, diventerebbe meno incisivo e convincente di quanto non sia nella prosa scabra e drammatica di Paolo; ma non si può avere tutto.
Non è che i ragionamenti qui giocosamente ipotizzati siano del tutto erronei in se stessi. Al contrario, contengono molta verità e vanno doverosamente compiuti, ma non come primo approccio alla realtà delle cose. Da essi non si può partire; ad essi si può solo approdare al termine di un lungo pellegrinaggio ideale: soltanto dopo che la visione della spaventosa miseria dell’uomo ci avrà aperto la mente e il cuore a desiderare e a capire la sospirata salvezza di Cristo, ci sarà consentito di apprezzare tutto quanto di bello, di giusto, di vero, riluce già nella notte del mondo, come riverbero del Redentore, che è la verità, la giustizia, la bellezza rese persona e divenute percepibili in un volto d’uomo.
Ogni autore cristiano ha sempre avviato il suo canto da un’ode tragica sull’umano destino per arrivare all’inno di vittoria e di gratitudine al Figlio di Dio crocifisso e risorto, unica nostra speranza, che solo ci ha ottenuto la salvezza.
L’uomo, che voglia celebrare veramente la propria grandezza, non può che principiare da un “epicèdio”, cioè da una lamentazione sullo stato di morte che enigmaticamente dall’inizio ha colpito l’universo e lo serra ancora in una morsa ineludibile.
Il fondamento dell’ottimismo cristiano non può essere la volontà di tener chiusi gli occhi. Bisogna per prima cosa guardare in faccia alla “Bestia” e renderci conto di quanto siano aguzzi i suoi denti e terrificanti i suoi artigli, se si vuole onorare e amare il “Cavaliere”, e si desidera capire davvero quale dono sia la nostra liberazione e la felicità che ci è stata assegnata in sorte.
(Giacomo Biffi “La Bella, la Bestia e il Cavaliere. Saggio di teologia inattuale.” JACA BOOK 1984)

Morto il card. Biffi. Il Papa: amò tenacemente la Chiesa

Il cardinale Giacomo Biffi -
Un vescovo che “ha servito con gioia e sapienza il Vangelo e ha amato tenacemente la Chiesa”. Papa Francesco ricorda così, in un telegramma di cordoglio, la scomparsa del cardinale emerito di Bologna, Giacomo Biffi, spentosi la notte scorsa, nella clinica felsinea dove era ricoverato da tempo, all’età di 87 anni. Per circa vent’anni – dal 1984 al 2003 – fu capo dell’arcidiocesi di Bologna come “guida sollecita e saggia”, scrive Francesco, che ne ricorda “l’instancabile servizio” alla “formazione umana e cristiana di intere generazioni”, sottolineando in particolare il “linguaggio diretto e attuale” col quale il porporato si poneva “al servizio della parola di Dio”. I funerali del cardinale Biffi saranno celebrati martedì mattina a Bologna nella cattedrale di San Pietro alle 10.30, presieduti dal cardinale arcivescovo di Bologna, Carlo Caffarra. Il servizio di Luca Tentori da Radio Vaticana:
"Si può allora anche dire che tutte le religioni hanno del buono e che tra esse si può scegliere a proprio gusto come si sceglie un libro da leggere o una musica da ascoltare. Si può dire, purchè non ci si dimentichi che il cristianesimo è un’altra cosa. Il cristianesimo è un fatto e i fatti non si scelgono, i fatti sono”.
Parole decise di un insegnamento chiaro e forte. Correva l’anno 1995 quando il cardinale Giacomo Biffi le rivolse ai giovani della sua città d’adozione: Bologna. A 87 anni, l’arcivescovo emerito del capoluogo emiliano, è morto questa notte in una casa di cura. Milanese, o meglio ambrosiano, è stato una figura di spicco dell’episcopato italiano negli anni ‘80 e ‘90. Era nato il 13 giugno del 1928, un dono di Sant’Antonio di Padova alla sua famiglia, come amava ricordare. Ordinato sacerdote per le mani del cardinal Ildefonso Schuster nel 1950 fu insegnante di teologia, parroco a Milano e ausiliare della diocesi meneghina fino al 1984 quando fu nominato arcivescovo di Bologna. Dopo le reticenze iniziali per l’incarico si innamorò presto della sua nuova Chiesa e decise di rimanervi a trascorrere gli ultimi anni della sua vita anche quando terminò il suo servizio pastorale nel 2003 per raggiunti limiti di età. Il suo pensiero di teologo e pastore non passava indifferente negli ambienti ecclesiali e della società Nel 1989 e nel 2007 ha predicato gli esercizi spirituali di quaresima a San Giovanni Paolo II a Benedetto XVI:
“Tre cose noi non dobbiamo dimenticare: la prima è che non siamo degli innocenti, siamo dei salvati. La seconda cosa è che possiamo ancora cadere. Ma noi sappiamo che il Signore è fedele e che vuol darci come dono quella perseveranza che non è nelle possibilità dell’uomo che confida in se stesso. La terza cosa è che di fronte alla debolezza e alle cadute dei nostri fratelli dobbiamo avvertire una specie di corresponsabilità che ci porti a condolerci con loro e talvolta anche a soffrire al loro posto. Al tempo stesso dobbiamo sentirci investiti e assimilati dall’onda della divina pietà, in modo da diventare nei confronti di chi sbaglia raffigurazione della misericordia del Signore”.
Ironico, pungente e schietto preferiva la sintesi alle frammentazioni del sapere e del pensiero teologico. Definì la sua Bologna “sazia e disperata”, organizzò nel 1997 il Congresso eucaristico nazionale a cui partecipò Giovanni Paolo II, rilesse le avventure di Pinocchio, era innamorato di Sant’Ambrogio e in uno dei suoi ultimi libri si definì un “italiano cardinale”. Difficile raccogliere in poche battute il suo impegno e il suo pensiero. Chiara la sua fede escatologica e il suo deciso cristocentrismo.
“La notte sta calando sulle illusioni umane. Essi non sanno o hanno dimenticato che il Signore è veramente risorto ed è con noi vivo e attivo tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Fateglielo sapere voi! Se vi impegnate in questo spenderete bene la vostra unica vita”.


Alle 2:30 dell'11 luglio è morto il cardinale Giacomo Biffi, arcivescovo emerito di Bologna e una delle figure più rappresentative della Chiesa italiana. Il 13 giugno scorso aveva festeggiato l’87° compleanno. Da mesi era ricoverato nella Clinica Toniolo di Bologna per seri problemi al sistema circolatorio. Gli ultimi tre anni e mezzo lo hanno consumato fisicamente e purificato spiritualmente, li ha vissuti con grande serenità e fede incrollabile.
di Luigi Negri e Giorgio Maria Carbone
- UN CARDINALE DALLA FEDE INCROLLABILE
di Giorgio Maria Carbone
Due mesi fa padre Giuseppe Barzaghi gli chiese cosa lo rendesse così sereno. Il card. Biffi gli rispose: «La considerazione dell’unitotalità che ho imparato leggendo i teologi russi e in particolare Solov’ëv», la considerazione che tutto è integralmente e simultaneamente presente allo sguardo di misericordia di Dio,
tutto, proprio tutto e quindi anche tutto l’arco della nostra esistenza e nulla di buono va smarrito nello sguardo divino.
È stato un maestro nella fede fino alla fine. Per amore di sinteticità – che lo stesso cardinale apprezzava – riduco a due punti il patrimonio inestimabile che ci ha lasciato in eredità.
1) La convinzione che il cristianesimo primariamente e per sé non è una religione – cioè un insieme di riti e di precetti che ci mettono in relazione con Dio – ma è piuttosto un fatto, il fatto di Gesù Cristo, che è il Verbo incarnato che ha vissuto in mezzo a noi, è morto, è risorto e ora vive nella gloria. Questo è un evento che è accaduto storicamente duemila anni fa e che accade tuttora grazie alla mediazione della Chiesa e dei sacramenti. Perciò essendo un fatto, il cristianesimo non può essere paragonato a nessun tipo di religione. Ed essendo un fatto, chiede a noi di prenderne atto e di comportarci di conseguenza, cioè seguire Cristo che è l’autore e il principe della vita e della gloria.
2) A proposito dell’articolato tema dell’immigrazione il cardinale era intervenuto più volte pubblicamente e aveva sempre distinto vari livelli di analisi. Alla Chiesa e ai credenti compete la pratica della carità e dell’apostolato verso tutti, credenti e non credenti: da ciò deriva l’impegno della Caritas e dell’annuncio di Gesù. Alla Repubblica Italiana compete il discernimento sulle persone degli immigrati e la gestione dei cosiddetti flussi tenendo conto di un semplice dato fattuale: l’Italia non è una landa deserta e desolata, ma ha una sua identità, una sua precisa e invidiabile cultura e quindi è ragionevole sostenere che se chi ci governa avesse a cuore la futura pacifica convivenza delle genti nella nostra penisola dovrebbe sempre considerare la volontà reale e concreta dell’immigrato di integrarsi nella cultura italiana. E infine agli immigrati competono tutti i diritti umani, ma mai il diritto di invasione.
Il Cardinal Biffi nella sua schietta concretezza meneghina ha ricondotto tutto ai fatti, perché come lui stesso diceva i fatti una volta accaduti nessuno li può più cambiare, neanche Dio, che è Amore onnipotente.

- UNA VITA "CRISTOCENTRICA"
di Luigi Negri
Il cardinale Biffi è stato senz'altro una grande intelligenza teologica, una delle più profonde e delle più vaste dell’ultimo secolo, raccolta attorno al grande tema di cui egli fu l’ispiratore, ovvero quello del “Cristocentrismo” assoluto, la centralità assoluta di Cristo come redentore dell’uomo e del mondo, centro del cosmo e della storia.
Raccolgo tutti i sentimenti, e tutti i pensieri che sorgono al ricordo del cardinale Giacomo Biffi, arcivescovo emerito di Bologna. Un «italiano cardinale», come disse in quel gigantesco volume di memorie che diventa una lettura obbligata per chi voglia capire qualche cosa di questo nostro «disgraziato paese», come diceva Renzo del ducato di Milano.
Il cardinale Biffi ha raccolto la più grande tradizione intellettuale e morale dello spirito e della storia ambrosiana. Una grande intelligenza teologica, una delle più profonde e delle più vaste dell’ultimo secolo, raccolta attorno al grande tema di cui egli fu l’ispiratore, ovvero quello del “Cristocentrismo” assoluto, la centralità assoluta di Cristo come redentore dell’uomo e del mondo, centro del cosmo e della storia. Da questa conoscenza di quell’unicum irriducibile e imparagonabile con qualsiasi altra formulazione di carattere religioso filosofico, sgorgava una visione ampia e concreta della realtà, quell’ampiezza del pensare cristiano a cui ritornava spesso recuperando la grande lezione di sant’Ambrogio e di san Tommaso d’Aquino.
I grandi temi della dogmatica cattolica fino a quelle pagine straordinarie sull’escatologia; quell’indagare ripetutamente sul mistero della Santa Chiesa esplorato secondo connotazioni e aspetti complementari; e poi la passione per la società, per il popolo e per la società. Quella visione della vita sociale che solo se è illuminata dall’esperienza della fede e animata dalla testimonianza dei cristiani può sfuggire alla tentazione di assolutizzarsi, cioè di diventare fonte di dominio sull’uomo, sulla sua verità.
Il cardinal Biffi ispirò al cardinale Giovanni Colombo, di cui fu un appassionato collaboratore, quei discorsi alla città che negli anni “70 segnarono l’inizio di una nuova e più profonda immanenza della Chiesa di Milano alla società milanese, che incominciò da allora quel cammino tormentato e lacerato che si è concluso in questi ultimi anni.
Cardinale di Bologna, una delle diocesi più difficili ma che assunse con un piglio giovanile, condusse con una chiarezza ideale e con una capacità pastorale che lo segnalano tra i più grandi vescovi di questa epoca.
Viveva un amore appassionato alla Chiesa e al popolo di Dio: il cardinale Biffi non era un populista, così come non lo è il sottoscritto. Siamo nati in due grossi quartieri della città di Milano e il popolo per noi non è stato oggetto di riflessioni o di valutazioni scientifiche o sociologiche; il popolo è stata l’esperienza quotidiana della dignità di tanti uomini che in forza della loro fede vivevano la fatica del lavoro, la responsabilità della famiglia e dell’educazione dei figli.
Protagonista di un magistero limpido e profondo, lontano dalla mentalità dominante, il cardinale Biffi non ha mai avuto il problema di cosa pensasse di lui la stampa; e me lo ha detto più volte. Mi diceva: «Il mio problema è cosa pensa di me Dio, cosa pensa di me la Chiesa, e cosa pensa di me il Papa».
Più di venti anni fa fece un intervento di grande prudenza e di grande intelligenza sul problema degli immigrati extracomunitari. Naturalmente fu respinto con la sufficienza tipica delle istituzioni politiche, un rifiuto di ascoltare che ha certamente aumentato la tragedia che quotidianamente verifichiamo. Se fosse stato ascoltato forse i problemi non sarebbero così devastanti.
L’ho visto l’ultima volta qualche settimana fa, subito dopo quella operazione che lo aveva privato di una gamba nel tentativo di frenare la cancrena che lo aveva assalito. Silenzioso mi ha guardato con occhi vivi, lucenti, interessati, appassionati sottolineando con l’approvazione della testa quello che andavo dicendo o con un diniego quando emergevano posizioni inassimilabili alla nostra posizione obiettivamente ortodossa.
Il cardinale Biffi ha saputo mostrare come la verità sia fonte di carità e la giustizia di Dio sia fonte della misericordia. Tutto questo apparteneva alla concezione pacifica della Chiesa e del rapporto fra la Chiesa e il mondo. Oggi la mediocrità invade la vita ecclesiastica e dissolve la vita sociale. Il cardinale Biffi è stato certamente un grande uomo di Chiesa, non mediocre, la cui grandezza risulterà man mano che il tempo passerà. Onore quindi - come si diceva una volta in tempi forti e non mediocri -, onore a lui e alla sua grande testimonianza di fede, di cultura e di paternità pastorale.
* Arcivescovo di Ferrara-Comacchio

[Modificato da Caterina63 13/07/2015 13:19] Fraternamente CaterinaLD
"Siamo mendicanti e chiediamo agli altri anche le loro idee, come la staffetta della posta che riceve il documento dalle mani di uno e poi corre per darlo ad un altro. Faccio una timida parafrasi delle parole di chi ci ha preceduto nel cammino della fede, per annunciarle ad altri."
(fr. Carlos Alfonso Azpiroz Costa OP
Maestro dell’Ordine) |
| | | OFFLINE | Post: 39.988 | Sesso: Femminile | |
|
 15/07/2015 15:43 15/07/2015 15:43 | |
«Il dialogo è evangelizzazione e la fede è giudizio» Ecco l’eredità che Biffi consegna alla Chiesa
di Carlo Caffarra, cardinale arcivescovo di Bologna
15-07-2015

Il cardinale Giacomo Biffi, «aveva un concetto molto alto del dialogo, e disprezzava profondamente chi lo praticava o come sforzo di ridurci tutti a un minimo comune denominatore o al perditempo della chiacchiera da salotto. In breve: il dialogo coincide con l’evangelizzazione”.
Lo ha detto l’arcivescovo di Bologna, il cardinale Carlo Caffarra, nella sua omelia al funerale del suo predecessore, morto a Bologna all’età di 87 anni.
Alla celebrazione in cattedrale migliaia i fedeli: fra loro il sindaco Virginio Merola, il ministro dell'ambiente Gian Luca Galletti, Pierferdinando Casini, il rettore dell'Università Ivano Dionigi, l'ex presidente del Senato Marcello Pera, l'ex sindaco Giorgio Guazzaloca.A concelebrare la messa, oltre ai vescovi dell’Emilia-Romagna, anche i cardinali Angelo Bagnasco e Dionigi Tettamanzi. Pubblichiamo il testo integrale dell'omelia del cardinale Carlo Caffarra.

«Venerati fratelli vescovi, carissimi fedeli tutti, la professione di fede detta da Pietro sotto divina rivelazione, risuona in questo momento in questa cattedrale. Il nostro fratello, il vescovo Giacomo, ha costruito la sua vita, il suo pensiero teologico, il suo ministero pastorale sulla roccia di quella professione: il Cristo, il Figlio - è stato l'incipit -. Sopra questa certezza, il nostro fratello, il vescovo Giacomo, ha edificato il suo cammino di fede, la sua profonda esperienza cristiana. Il cristianesimo, egli scrive, “primariamente e per sé è un fatto, il fatto della morte, della risurrezione, della totale e perenne vitalità in atto di Gesù di Nazareth”. Quando l’apostolo Paolo volle come riassumere tutta la sua predicazione, e il senso del suo faticoso ministero, scrive: “vi ho trasmesso…anzitutto quello che anch’io ho ricevuto, che cioè Cristo morì per i nostri peccati secondo le Scritture, fu sepolto ed è risuscitato il terzo giorno secondo le scritture”. É la parola che proviene da questa bara».
«Benché morto il vescovo Giacomo parla ancora, e ci dice: questo è il Vangelo che vi ho annunziato eche voi avete ricevuto, nel quale restate saldi, e dal quale ricevete la salvezza, se lo manterrete in quella forma in cui ve l’ho annunziato. Alla luce di questa lucida consapevolezza della grandezza, del primato dell’imparagonabile unicità del Signore Gesù e dei suoi Misteri, possiamo comprendere uno degli aspetti, delle dimensioni della persona e del ministero del vescovo Giacomo. Consentitemi di dirvelo attraverso una confidenza fattami da uno dei più grandi medici del secolo scorso. “Amo troppo ogni ammalato per non odiare ogni malattia”. Il vescovo Giacomo amava profondamente “la bella Sposa, che s’acquistò con la lancia e coi clavi”. Sentiva come una sorta di gelosia perché la sposa non guardasse con desiderio altri all’infuori di Cristo. Egli amava ripetermi di non fare alcuna fatica ad osservare il nono comandamento, poiché la sposa che il Papa gli aveva dato – la Chiesa di Bologna – era così bella da non desiderarne altre. É da questa mistica gelosia che nasce la messa in guardia di questo gregge santo di Bologna dagli errori, dimostrandone – a volte in modo tagliente – l’intima inconsistenza. Egli aveva un concetto molto alto del dialogo, e disprezzava profondamente chi lo praticava o come sforzo di ridurci tutti a un minimo comune denominatore o al perditempo della chiacchiera da salotto. In breve: il dialogo coincide con l’evangelizzazione».
«Egli aveva una grande venerazione della fede dei piccoli, dei semplici, e non permetteva che fosseminimamente vulnerata da sedicenti teologie. Parlando dei poveri, dei semplici non posso tacere un aspetto poco conosciuto del suo ministero: l’esercizio della carità verso chi si trovava in difficoltà di ogni genere. Anche economiche. Carissimi fratelli vescovi, carissimi fedeli, compio ora il grato dovere di testimoniare che il vescovo Giacomo fu maestro di fede anche nella lunga tribolazione della malattia. Non potrò mai dimenticare il modo con cui accettò l’amputazione di una gamba. Il volto emanava serenità, pace, abbandono. La fede era diventata vita nel senso più profondo. Egli ci ha fatto conoscere il mistero della sua volontà…il disegno cioè di ricapitolare in Cristo tutte le cose. Carissimi fratelli vescovi, carissimi fedeli, il fatto che il nostro vescovo Giacomo vivesse come una sorta di con-centrazione in Cristo, non solo non lo distoglieva dalla vicenda umana, ma nel suo cristocentrismo ne trovava la chiave interpretativa ultima. Cari amici, possiamo considerare la confusa vicenda umana come potremmo guardare un ricamo. La parte inversa è una gran confusione di fili; la parte retta è un disegno intelligibile. La concentrazione cristologica che caratterizza la vita ed il magistero del nostro vescovo Giacomo, gli consente di vedere dentro le vicende umane il disegno del Padre. Ho potuto constatare più di una volta che quando parlava del disegno di Dio dentro la storia umana, era preso come da una sorta di incanto che lo affascinava».
«Un religioso, visitandolo negli ultimi giorni, meravigliato dalla sua serenità e pace interiore, glienechiese la ragione. Rispose: “La considerazione dell’unitotalità che ho imparato leggendo i teologi russi”. Cioè la considerazione che tutto è integralmente e simultaneamente sotto lo sguardo della misericordia di Dio. Questo modo di guardare la realtà gli dava una grande libertà di giudizio – ubi fides, ibi libertas: era il suo motto - sui fatti di oggi e del passato, anche dal punto di vista rigorosamente storico. Possiamo dire, usando le parole di S. Massimo il Confessore, che il nostro vescovo Giacomo ci ha insegnato a pensare ogni cosa per mezzo di Gesù Cristo, e Gesù Cristo per mezzo di ogni cosa. E Dio solo sa quanto oggi nella nostra Chiesa italiana abbiamo bisogno di una fede capace di generare un giudizio sugli avvenimenti. “Ricordatevi dei vostri capi, i quali vi hanno annunziata la parola di Dio; considerando attentamente l’esito del loro tenore di vita, imitatene la fede” [Eb 13, 7]. Questa è la raccomandazione che l’autore sacro fa ai suoi fedeli. La Chiesa non può, non deve perdere la sua memoria, ma deve custodire i suoi “ricordi” fedelmente.
«Fra poche ore il nostro vescovo Giacomo sarà deposto nel sepolcro in attesa della beataresurrezione. Scomparirà del tutto la sua presenza visibile, ma deve essere depositata nella memoria della nostra Chiesa la testimonianza di chi ci ha annunciata la parola di Dio. Cioè: “Cristo è tutto in tutti”. “É finito il tempus faciendi”, scriveva quando si ritirò, “i miei giorni residui sono diventati soprattutto il tempo dell’attesa”. Ora anche il tempo dell’attesa si è compiuto. Prega per noi pastori soprattutto, caro fratello, perché non dimentichiamo mai che la più grande povertà dell’uomo è non conoscere Gesù Cristo"»

Fraternamente CaterinaLD
"Siamo mendicanti e chiediamo agli altri anche le loro idee, come la staffetta della posta che riceve il documento dalle mani di uno e poi corre per darlo ad un altro. Faccio una timida parafrasi delle parole di chi ci ha preceduto nel cammino della fede, per annunciarle ad altri."
(fr. Carlos Alfonso Azpiroz Costa OP
Maestro dell’Ordine) |
| | | OFFLINE | Post: 39.988 | Sesso: Femminile | |
|
 05/05/2016 19:47 05/05/2016 19:47 | |
 Casta meretrix ovvero “doppiamente santa” Casta meretrix ovvero “doppiamente santa” L'ideologia postconciliare L'ideologia postconciliare Per una cultura cristiana Per una cultura cristiana A proposito di “dialogo” A proposito di “dialogo” Il vescovo che non stava al suo posto Il vescovo che non stava al suo posto

| L'ideologia postconciliare |
|
di Giacomo Biffi
[Da "La Bella, la Bestia e il Cavaliere. Saggio di teologia inattuale", Jaca Book, Milano 1984]
Essa deriva sì storicamente dal Vaticano II e dal suo magistero, ma attraverso un processo di "distillazione fraudolenta" immediatamente posto in atto all'indomani dell'assise ecumenica.
L'operazione potrebbe schematicamente essere descritta così:
- la prima fase sta nella lettura discriminatoria dei passi conciliari, che distingue tra quelli accolti e citabili, e quelli da passare sotto silenzio;
- nella seconda fase si riconosce come vero insegnamento del concilio non quello effettivamente formulato, ma quello che la santa assemblea ci avrebbe dato se non fosse stata afflitta dalla presenza di molti padri retrogradi e insensibili al soffio dello Spirito;
- con la terza fase si arriva a dire che la vera dottrina del concilio non è quella di fatto canonicamente approvata ma quella che avrebbe dovuto essere approvata se i padri fossero stati più illuminati, più coraggiosi, più coerenti.
Con un metodo esegetico siffatto - non enunciato mai in modo esplicito, ma non per questo meno implacabilmente applicato - è facile immaginare i risultati.
I quali, per quanto remoti siano dalla verità cattolica, vengono sempre messi in conto al Vaticano II; e chi si azzarda anche timidamente a dissentire è segnato col marchio infamante di "preconciliare", quando non addirittura classificato coi tradizionalisti ribelli o con gli esecrati integralisti.
E poiché tra i "distillati di frodo" dal Vaticano II c'è anche il principio che nessun errore puo' essere condannato nella Chiesa a meno di peccare contro il dovere della comprensione e del dialogo, nessuno osa più denunciare con vigore e con tenacia i veleni che stanno progressivamente intossicando il popolo di Dio. 
| Casta meretrix ovvero “doppiamente santa” |
|
del Card. Giacomo Biffi - Arcivescovo emerito di Bologna
Per molti teologi e “saccenti”, la Chiesa sarebbe anche peccatrice. Lo testimonierebbe l’espressione “casta meretrice” attribuitale, dicono, dai Padri. Ma siamo sicuri che abbiano ragione? Pare proprio di no. Vediamo perché.
[Da «il Timone» n. 59, gennaio 2007]
Annotazione previa
La Chiesa è santa o peccatrice? Nessuno degli antichi simboli di fede si dimentica di elencare anche la santità della Chiesa tra le verità che appartengono al patrimonio delle certezze cristiane. Ma nell’insegnamento dei teologi professionisti - e conseguentemente in larga parte della coscienza ecclesiale dei nostri giorni - quale rilevanza assume questo punto della dottrina cattolica? Tutelare una persuasione che ci viene dall’insegnamento degli apostoli - anzi, se è possibile, avvalorarla nella mentalità ecclesiale contemporanea - è, a mio giudizio, un compito ineludibile della pastorale di oggi: ineludibile ma, a essere schietti, abbondantemente eluso. Viene oggi efficacemente proposta, tra tutte le verità della fede, anche quella della santità della Chiesa?
Moderna fortuna di un termine
«Casta meretrix» è un sorprendente oximoron ("espressione antinomica"); tanto più sorprendente perché è abitualmente riferito alla Chiesa. Dopo l’ambigua utilizzazione di von Balthasar (in Sponsa Verbi,Brescia 1985) esso gode di una discreta fortuna. Ogni tanto me lo sento ricordare, con la soddisfazione di chi è certo di addurre un’argomentazione decisiva allorché dichiaro incautamente la mia convinzione che alla Chiesa come tale non si possa assegnare l’epiteto di «peccatrice». «Ma se la Chiesa - mi si ribatte - è una "casta meretrix", come dicono i Padri!». È così enfatico l’accento posto sul sostantivo, che l’aggettivo che l’accompagna passa in seconda linea. «Come dicono i Padri». Dir male della Chiesa (che nessuna antica professione di fede si dimentica di chiamare «santa») non è mai stato ritenuto nell’ascesi cristiana un atto particolarmente meritorio. È piuttosto da sempre l’inveterata consuetudine degli «altri», cioè dei non credenti. È consentito ai buoni fedeli , associarsi al coro dei maldicenti, magari per favorire un dialogo aperto e costruttivo? I più timorati non ne troverebbero il coraggio se non potessero aggiungere appunto:«Come dicono i Padri».
«Come dicono i Padri»
A sentirli, si direbbe che ci sia quasi un consenso universale; che nessuno dei grandi maestri di fede dei primi secoli si sia dimenticato di attribuire alla Chiesa questo titolo pittoresco: che la denominazione «casta meretrix» sia un punto irrinunciabile di tutta l’ecclesiologia tradizionale. (Citiamo per tutti H. Kung, che qui si dimostra più sicuro delle sue asserzioni che non premuroso di documentarle: «C’è solo una chiesa che è al tempo stesso santa e peccatrice, una "casta meretrix", come fin dall’epoca patristica la si è spesso chiamata...» (H. Kung, La chiesa, Brescia 1969, p. 379).
«Come dicono i Padri»: avvalorato da così ampia e autorevole testimonianza, un cuore cattolico si rassicura e può tranquillamente parlare dei "peccati della Chiesa". Ma siamo sicuri che questi teologi non siano a questo proposito un po’ faciloni e spensierati? Vediamo allora, con un’indagine di una certa serietà, quanti sono questi Padri. E vediamo chi sono. Salvo miglior giudizio, è uno solo: Ambrogio. Nessuno ha parlato di «casta meretrix» prima di lui, e nessuno dopo di lui, tra i Padri, l’ha imitato.
Rahab «tipo» della Chiesa
Ambrogio ha usato questa espressione una sola volta, nella sua meditazione su Rahab, la donna di Gerico di cui parla il libro di Giosuè.
Essa – egli dice - «nel simbolo era una prostituta ma nel mistero era la Chiesa, congiunta ormai ai popoli gentili per la comunanza dei sacramenti» (In Lucam VIII,40).
L’utilizzazione «tipica» di Rahab - personaggio contraddittorio, cui era attribuita sia una professione indegna sia un’azione lodata e provvidenziale - era già un classico della letteratura cristiana. Il Vangelo di Matteo l’aveva ricordata nella genealogia di Gesù (cf. Mt 1,5). La lettera agli Ebrei l’aveva portata come esempio della fede che salva (cf. Eb 11,31). San Giacomo, preso da altre preoccupazioni teologiche, aveva messo in risalto la sua giustificazione ottenuta con le opere, cioè con la buona azione a vantaggio degli esploratori ebrei (cf. Gc 2,25). Clemente Romano, quasi a sintesi e conciliazione dei due testi, aveva scritto: «Per la sua fede e la sua ospitalità Rahab la meretrice fu salva» (I ad Corinthios 12,1).
Dopo Clemente, che si sofferma a lungo sull’episodio di Gs 2,1-21, leggendolo alla luce della redenzione operata da Cristo (cf. I ad Corinthios 12,1-8), era andata chiaramente delineandosi - da Giustino a Ireneo a Origene a Cipriano - una decisa interpretazione ecclesiologica della figura di Rahab. E proprio dalla riflessione sulla «casa della prostituta» - la sola in Gerico che ha preservato dalla morte - emerge il famoso principio che «fuori della Chiesa non c’è salvezza».
«Nessuno potrebbe illudersi al riguardo - scrive Origene - nessuno può ingannarsi: fuori di questa casa, cioè fuori della Chiesa, non c’è salvezza» (Om. in Iosue 3,4). E Cipriano: «Credi tu di poter vivere, se ti distacchi dalla Chiesa edificandoti altre case e diversi alloggi, mentre a Rahab, prototipo della Chiesa, viene detto: ognuno che lascerà la porta della tua casa sarà colpevole?» (De unitate eccesiae, 8). In Cipriano il principio «extra Ecclesiam nulla salus» viene collegato con la verità della maternità della Chiesa: «non può avere Dio per padre, chi non ha la Chiesa per madre» (De unitate ecclesiae 6).
Che significa «casta meretrix»?
Ambrogio nella sua riflessione ha presumibilmente sottocchio soprattutto il commento di Origene. Ma il suo pensiero si sviluppa in maniera molto personale.
«Rahab - che nel tipo era una meretrice ma nel mistero è la Chiesa -indicò nel suo sangue il segno futuro della salvezza universale in mezzo all’eccidio del mondo: essa non rifiuta l’unione con i numerosi fuggiaschi, tanto più casta quanto più strettamente congiunta al maggior numero di essi; lei che è vergine immacolata, senza ruga, incontaminata nel pudore, popolare nel suo amore, meretrice casta, vedova sterile, vergine feconda» (In Lucam III,23). Questo è l’unico passo dove compare la nostra espressione; e merita un commento ravvicinato.
Typo meretrix mysterio ecclesia - Si vuol dire che l’attività meretricia appartiene alla «figura», non alla realtà figurata. Non si possono dunque fare frettolose trasposizioni dal «tipo» all’«antitipo»; bisogna prima chiarire in che senso e sotto quale profilo il paragone possa essere istituito.
Multorum convenarum copulam non recusat - Il chiarimento arriva immediatamente: la Chiesa può essere simbolicamente ravvisata nella donna di Gerico, soltanto perché non si rifiuta di unirsi alla moltitudine dei «fuggiaschi», cioè di quanti - dispersi e disorientati nella città mondana - cercano presso di lei riparo dalla perdizione. Tutti li accoglie per tutti salvarli.
Quo coniunctior pluribus eo castior - C’è però una differenza fondamentale. La condiscendenza con cui la Chiesa dischiude la sua porta a tutti, come fanno le donne di costumi troppo facili, non solo non comporta in lei niente di riprovevole, ma indica addirittura fedeltà alla propria missione (e quindi al suo Sposo che gliel’ha assegnata).
Immaculata virgo, sine ruga, pudore integra - Quasi a prevenire qualunque equivoco che potesse nascere da un paragone innegabilmente audace, è evocato qui (e perfino oltrepassato) l’appassionato linguaggio di Paolo quando esalta «la Chiesa senza macchia né ruga né alcunché di simile» (Ef 5,27). È da notare che nel testo di Ambrogio non si tratta della condizione escatologica cui il Signore vuoi portare la sua Sposa. «Immaculata virgo, sine ruga, pudore integra» è per il vescovo milanese proprio la Chiesa che, camminando nella storia, accoglie e salva gli uomini che oggi sono «sbandati» («convenae»).
Amore plebeia ("popolare nell’amare") - L’espressione è un po’ avventurosa, ma ricca di una intensità che la rende quasi intraducibile. «Plebeius» negli scrittori latini è vocabolo che ha sempre almeno una sfumatura di spregio. Che abbia potuto venire adoperata da un patrizio di eccellente cultura romana per qualificare la Sposa di Cristo, basta a significarci la novità "democratica" davvero rivoluzionaria portata dal cristianesimo. La Chiesa è «plebeia» nel suo amore; vale a dire, non c’è niente di aristocraticamente esclusivo nelle sue attenzioni, che sono rivolte a tutti senza distinzione. O, se ci sono preferenze, sono casomai per i semplici, gli umili, i poveri. Ambrogio, si sa, aveva un po’ in antipatia le condizioni di privilegio, tanto che ha potuto scrivere: «Nessuno presuma, perché è ricco, che gli si debba maggior ossequio. Nella Chiesa è ricco chi è ricco di fede» (Ep. Extra coli. 14,86).
Tre immagini
La meditazione ecclesiologica ambrosiana si avvale in quel brano di tre immagini, da considerarsi simultaneamente se si vuol attingere la profondità del mistero. La Chiesa è al tempo stesso prostituta, vedova, vergine: «meretrix casta, vidua sterilis, virgo fecunda». E ci viene subito offerta una limpida spiegazione di queste tre qualifiche
La Chiesa è «meretrice casta, perché molti amanti la frequentano per le attrattive dell’amore ma senza la contaminazione della colpa».
La Chiesa è «vedova sterile, perché in assenza del marito non sa generare (ma poi il marito è giunto, e così ella ha generato questo popolo e questa "plebe")». La Chiesa è «vergine feconda, perché ha partorito questa moltitudine, come frutto del suo amore, non però per intervento di concupiscenza» (In Lucam III,23).
Concludendo
Nel suo significato originario, dunque, l’espressione «casta meretrix», lungi dall’alludere a qualcosa di peccaminoso e di riprovevole, vuole indicare - non solo nell’aggettivo ma anche nel sostantivo - la santità della Chiesa; santità che consiste tanto nell’adesione senza tentennamenti e senza incoerenze al suo Sposo («casta») quanto nella volontà di raggiungere tutti (secondo il compito che le è stato affidato dal suo Signore) per portare tutti a salvezza («meretrix»).
E non appartiene «ai Padri» ma al solo Ambrogio, che nella spregiudicata libertà del suo animo credente l’ha coniata con l’unico intento di esaltare la Sposa di Cristo. E non dimentichiamolo: la fede di Ambrogio - notava già sant’Agostino - è la fede cattolica (Contra lulianum opus imperfectum 3,205: «secundum ambrosianam idest catholicam fidem»).
© il Timone
http://www.iltimone.org/

di Giacomo Biffi
La necessità che gli uomini debbano dialogare tra loro è quasi un’ovvietà: come potrebbero convivere gli abitanti di un pianeta così fortemente comunicante e unificato, senza parlarsi e confrontarsi tra loro? E possiamo anche essere d’accordo sulla doverosa ricerca della reciproca comprensione attraverso una benevola attenzione “all’altro”, che è il significato generalmente assunto dal termine “dialogo” nella cultura attuale. Ma oggi e diventato un tema cosi diffuso ad enfatizzato, che qualche riflessione sul dialogo - specificamente sul dialogo tra i credenti e non credenti - sembra meritare qualche attenzione.
[Da "il Timone" n. 35, luglio/agosto 2004 ]
L’enciclica Ecclesiam suam
Paolo VI, appena arrivato al sommo pontificato, si è reso conto che la parola “dialogo” nella mentalità generale era ormai diventata emergente e quasi mitica, acquistando un’innegabile rilevanza culturale. Generosamente e intelligentemente ha cercato allora di darle legittima cittadinanza entro l’insegnamento della Chiesa, adoperandosi al tempo stesso a orientare e a regolare la riflessione in proposito. Appunto all’argomento del “dialogo” è dedicato oltre un terzo della sua prima enciclica Ecclesiam Suam. Presentando il «dialogo» come dovere ecclesiale ineludibile, egli non aveva inteso certo attenuare o mettere in ombra il compito di evangelizzazione che il Signore risorto aveva dato alla sua Chiesa.
Il «dialogo» — nota l’enciclica — è la nuova forma del perenne slancio apostolico: «Noi daremo a questo impulso di carità, che tende a farsi dono di carità, il nome, oggi comune, di dialogo».
L’ammonimento dl Paolo VI
Non è che non si rendesse conto del rischio di malintesi ed esagerazioni implicito in affermazioni cosi inedite e forti: si preoccupa anzi di prevenirlo. Perciò riafferma la supremazia dell’annuncio esplicito e della predicazione, avvertendo: «La sollecitudine ad accostare i fratelli non deve tradursi in una attenuazione, in una diminuzione della verità. Il nostro dialogo non può essere una debolezza rispetto all’impegno verso la nostra fede. L’apostolato non può transigere con un compromesso ambiguo rispetto ai princìpi di pensiero e di azione che devono qualificare la nostra professione cristiana... Solo chi e pienamente fedele alla dottrina di Cristo può essere efficacemente apostolo».
Le intemperanze postconciliari
Nell’epoca post-conciliane, invece, tra i cristiani e gli ecclesiastici è affiorata talvolta una prospettiva che finiva col presentare il «dialogo» non come una condizione benefica e in una certa misura doverosa dell’annuncio evangelico e della stessa presenza cristiana nel mondo, ma come un valore assoluto, indipendentemente dai suoi contenuti e dai suoi risultati. A sentire certi pronunciamenti sembrerebbe quasi che da taluno si sia identificato nel «dialogo» l‘intero contenuto della fede cristiana, sicché il «dialogare» sarebbe già per se stesso obbedire alla missione fondamentale di predicare il Vangelo.
Possibilità di un dialogo “naturale”
È ovvio che qualsiasi forma di dialogo è possibile solo a misura che tra gli interlocutori ci sia qualcosa di comune. Ora gli esseri costituiti nell’identica natura umana hanno in comune tutto un patrimonio di concetti, di regole logiche, di interessi, di sentimenti; ed e una verità che non dobbiamo dimenticare mai. Perciò tra gli uomini — pur dissimili per carattere, cultura, appartenenza etnica e sociale — c’è sempre spazio per qualche scambio e per qualche intesa. Ed è già una base preziosa di relazione, che consente ai credenti e ai non credenti di arrivare a convincimenti condivisi e a collaborazioni preziose nel campo operativo: civile, sociale, assistenziale, solidaristico; e anche nell’individuare possibili convergenze politiche al servizio di una pace vera, di un reale progresso e della difesa della dignità umana.
Fede e incredulità
Se però vogliamo occuparci specificamente del rapporto tra il credente in quanto credente e il non credente in quanto non credente nelle questioni fondamentali e decisive dell’esistenza, è naturale che i nostri interrogativi possano trovare risposta solo se si chiarisce che cosa sia propriamente la fede — cioè l’elemento che con la sua presenza o la sua assenza diversifica la condizione del credente e dell’incredulo — e che cosa di fatto comporti nella vita spirituale e intellettuale del singoli.
La fede è atteggiamento integrale dell’uomo che coinvolge tutte le sue facoltà, dotandole di potenzialità che eccedono l’ambito puramente culturale. La fede è un’intelligenza assolutamente nuova e imparagonabile, che ci deriva dalla luce comunicataci dallo Spirito del Signore risorto: tale luce ha come effetto proprio di farci partecipare alla conoscenza stessa che possiede Gesù glorificato alla destra del Padre. «Credere» vuol dire dunque guardare la realtà con gli occhi del Risorto.
Chi è investito di questa luce superiore è in grado di contemplare il disegno che e stato pensato e voluto per questo ordine di provvidenza; disegno che non è coartato entro l’entità creaturale delle cose ma ha un significato, uno scopo, un traguardo che la trascende. Chi invece ne è privo, non cogliendo il disegno unificante di Dio, non può esaurire l’intelligibilità di nessun esistente, perché, ogni esistente in concreto è «vero» solo in quanto e inserito nella «unitotalità» del progetto ed e finalizzato ad esso; se ne è avulso e isolato, non è più colto nella sua piena autenticità.
È l’insegnamento di san Paolo in uno dei passi neotestamentari più importanti e oggi più trascurati: “L’uomo naturale [psichòs, cioè l’uomo non credente] non comprende le cose dello Spirito di Dio; esse sono follia per lui… L’uomo spirituale invece [pneumaticòs, cioè l’uomo credente] giudica ogni cosa.
I limiti del dialogo
Ci può essere possibilità di intendersi tra chi in virtù di questa luce superiore vede le cose come stanno e chi, sprovvisto di questa luce, non le vede? Senza dubbio, ci possono essere colloqui e affinità di vedute circa i singoli esseri, e solo in quanto sono opachi, frammentati, senza destino; ma non su ciò che davvero conta e importa nella nostra vita. Per esempio, non sul significato dell’universo, non sull’uomo che ha come sua indole propria di essere immagine di Cristo, non sul matrimonio che è annuncio e figura del mistero sponsale che connette la creazione al Creatore, non sull’amore, sulla giustizia, sulla bellezza, e sul fondamento ultimo di questi valori. Eccetera. Ascoltare su questi temi i discorsi di coloro che onorano Cristo e la sua causalità esemplare e finale nei confronti di ogni essere, è pressappoco come ascoltare i giudizi su un’esecuzione musicale di chi fosse sordo dalla nascita o le disquisizioni di chi è sempre stato cieco sul cromatismo di un maestro della pittura.
Sara dunque meglio persuadersi che non potrà essere né facile né frequente la convergenza sia pure parziale tra coloro che affermano e coloro che negano un disegno divino all’origine delle cose; coloro che affermano e coloro che negano una vita eterna oltre la soglia della morte; coloro che affermano e coloro che negano l’esistenza di un mondo invisibile, di là della scena variopinta e labile di ciò che appare; coloro che credono e coloro che non credono nel Signore Gesù, crocifisso e risorto, Figlio unico e vero del Dio vivente, salvatore dell’universo.
Le comunità cristiane devono affrontare ad occhi aperti, con serenità e con vigore di spirito, le inevitabili tensioni tra le diverse “culture” che di fatto convivono nell’ambito di una società pluralistica.
L’evento cristiano
Il dialogo interreligioso in particolare dovrà sempre fare i conti con una certezza per noi irrinunciabile; e cioè che l’evento salvifico - nei due fatti fondamentali dell’incarnazione del Verbo e della risurrezione di Gesù - non solo sta all’origine del cristianesimo, ma ne costituisce in modo perenne e definitivo il senso, il “cuore”, la ragione d’identità. Essendo un “evento” e non una pura dottrina, non è “trattabile” e non consente un accoglimento parziale: o lo si accetta o lo si rifiuta. Di conseguenza, esso e, per cosi dire, culturalmente “lacerante”: il credente non può - se vuol restare intellettualmente onesto - né attenuare quei due “fatti” né metterli tra parentesi né evitarli nel desiderio di essere ritenuto comprensivo e “politicamente corretto”. Il Signore ci aveva preavvisato: “Pensate che io sia venuto a portare la pace sulla terra? No, vi dico, ma la divisione” (Lc 12,51); frase che ai nostri giorni dà l’impressione di essere soggetta a qualche censura.
La libera azione dello Spirito
Una “teologia del dialogo” compiuta ed equilibrata non può però disattendere un altro dato del problema. All’azione dello Spirito Santo effuso sull’umanità dal Signore che sta alla destra del Padre non si possono assegnare confini: il Paraclito può illuminare chi vuole, anche al di fuori della cattolicità. In realtà, le intelligenze umane, se si pongono sinceramente al servizio della verità, vengono in alcuni momenti “pneumatizzate” (cioè paste sotto l’influsso del “Pneuma”), anche se di solito non arrivano a percepirlo.
Anzi, appunto perché il disegno salvifico di Dio è unico e unificante, dovunque c’è un disinteressato culto della sapienza lì opera lo Spirito che purifica le menti e le rende feconde. È ciò che voleva dire san Tommaso d’Aquino, con la frase che amava ripetere: “Ogni verità, da chiunque sia detta, viene dallo Spirito Santo”.
Il non credente può essere talvolta portavoce inconsapevole dello Spirito; perciò dobbiamo stare sempre in un atteggiamento di ascolto, per cogliere qualche scintilla di luce (cioè qualche asserto a qualche parere consonante col disegno del Padre e con il Vangelo di Cristo) anche dalle bocche che non ci aspetteremmo. Si rende, come si vede, indispensabile un atteggiamento ai tempo stesso di rispetto e di vigilanza, che sappia accuratamente soppesare e vagliare. È la raccomandazione di Paolo: “esaminate tutto, tenete ciò che è buono” (1 Ts 5,21).
Conclusione
Tutta la riflessione sul “dialogo” va condotta senza superficialità o spensieratezza, perché la pasta in gioco è altissima: ci può essere il rischio in nome di una improvvida durezza o intransigenza, di accostare gli “altri” senza amore, dimenticandosi che tutti gli uomini senza eccezioni (per il fatto di essere stati creati in Cristo sono immagini sempre vive dell’unico Signore dell’universo, della storia e dei cuori; ma c’è anche il rischio per noi con una incauta apertura scambiata per magnanimità, di non riconoscere più in pratica Gesù Cristo come l’unico maestro di vita, l’unico Salvatore dell’uomo, l’unico vero senso dell’esistenza: e quindi di non essere più in grado di presentarci chiaramente ed efficacemente come suoi testimoni “fino agli estremi confini della terra” (At 1,8).
© il Timone
 Fraternamente CaterinaLD
"Siamo mendicanti e chiediamo agli altri anche le loro idee, come la staffetta della posta che riceve il documento dalle mani di uno e poi corre per darlo ad un altro. Faccio una timida parafrasi delle parole di chi ci ha preceduto nel cammino della fede, per annunciarle ad altri."
(fr. Carlos Alfonso Azpiroz Costa OP
Maestro dell’Ordine) |
| | | OFFLINE | Post: 39.988 | Sesso: Femminile | |
|
 05/05/2016 21:53 05/05/2016 21:53 | |
| Per una cultura cristiana |
|
di Giacomo Biffi, cardinale
Partendo dai molti significati della parola cultura, mons. Biffi evidenza le caratteristiche della cultura cristiana e l’intima connessione con le fede. Riconciliazione nella verità.
[da una lettera del 1985]
Premesse
1. Arrivato imprevedutamente alla guida della Chiesa bolognese, mi avvedo che la connessione fede‑cultura e la problematica che ne consegue si impongono con urgenza come oggetto necessario della mia riflessione di pastore. E al tempo stesso si impongono a chiunque voglia capire la vocazione e l’anima di questa città. La fede cristiana marca fortemente la storia di Bologna: ne sono testimonianza i mille segni religiosi che si incontrano nelle sue strade e nelle sue piazze. E non sono memorie di un passato estinto per sempre: basterebbe a convincercene lo spettacolo annuale dell’omaggio alla Madonna di san Luca e le molteplici iniziative di carità che fioriscono tra noi, senza chiasso ma con ammirevole efficacia.
Ma questa è anche una città che respira cultura: la presenza tra le nostre mura di una grande Università, che fin dal Medioevo ha reso celebre il nostro nome nel mondo, caratterizza in questo senso tutta la nostra vita associata. Così mi è parso doveroso dedicarmi un poco a questo tema, che del resto entro le comunità crístiane attira da qualche anno molta attenzione. La mia riflessione vuole avere un’indole spiccatamente pastorale: si rivolge in primo luogo ai credenti e mira a illuminare e a rinvigorire la nostra vita ecclesiale; ma potrà suscitare qualche interesse per quanti siano persuasi che l’esatta determinazione dei concetti è premessa indispensabile per un fruttuoso dialogo tra uomini che siano, pur se con ideali diversi, liberi, onesti, riflessivi.
2. La natura propriamente pastorale del discorso mi consiglia di limitare la mia attenzione alla questione ‑ preliminare in un certo senso, ma decisiva per le possibili implicazioni ‑ dell’esistenza, della possibilità, della necessità di una “cultura cristiana”. C’è, anche tra i credenti, chi rifugge dal parlare di cultura cristiana nel lodevole proposito, crederei, di non costringere i letterati, i filosofi, i pittori, i musicisti ‑ e in genere gli uomini colti e creativi che professano di aderire al Vangelo ‑ a tagliarsi fuori dalla variopinta complessità del mondo culturale moderno per rinchiudersi nelle angustie della provincia ecclesiastica e confessionale. Sicché si ama parlare al massimo di “cultura dei cristiani”. Per contro Giovanni Paolo II esorta ripetutamente a “non far mancare una forte, seria, operosa presenza culturale cattolica”. “La cultura cattolica ‑ dice ‑ non deve mancare” (1). E non è un pensiero proprio ed esclusivo del papa polacco: Paolo VI si esprimeva nell’identico modo; tanto è vero che (come rileva in uno studio accurato Enzo Giammancheri) “usa senza velatura alcuna l’espressione "cultura cristiana", anzi "cultura cattolica", aggiungendo sovente la precisazione che si tratta della "nostra" cultura, distinta dalle altre e idonea a qualificare in modo originale il pensiero e l’azione dei credenti. In lui non c’è dubbio in proposito”(2).
3. Non mi pare si tratti di una questione puramente verbale. O, se si vuole, è probabilmente uno dei casi dove la diversità di linguaggio è sicuro indizio di opposte visioni sulla natura delle cose; è dunque un problema che chiede di essere seriamente considerato. E’ comunque certo che anche qui, senza una sufficiente determinazione dei concetti e dei termini, s’instaura inevitabilmente il regno dell’approssimazione, dell’equivoco, del malinteso. A questa chiarificazione il mio intervento vuol essere un piccolo contributo, offerto nella persuasione che le idee chiare e distinte sono la premessa inderogabile di ogni auspicata concordia e di ogni accresciuta vitalità ecclesiale; o almeno nella convinzione della necessità che, se proprio si deve discutere e litigare tra cristiani, l’oggetto del contendere sia identicamente compreso da tutti.
I. I significati fondamentali di “cultura”
“Cultura” è oggi parola usatissima e quasi mitica, come in altra epoca la parola “progresso”. La si ritrova ricordata ed esaltata da tutte le parti; e da tutti è citata come indicativa di un “valore”. Ma quale sia questo valore raramente si dice.
E’ anzi evidente che il vocabolo esprime, a seconda dei contesti e a seconda di chi se ne serve, contenuti tra loro molto diversi. Qualche volta appare cangiante di senso perfino nello stesso discorso, nella stessa pagina, nella stessa frase. In molti casi neppure si avverte l’oscillazione semantica, così che il risultato è una bella confusione.
La ragione storica di questa incontrollata e quasi inconsapevole pluralità sta nel fatto che la parola da un paio di secoli ha assunto via via significati nuovi, senza che le accezioni già in uso siano mai cadute dalla coscienza comune.
Decine e decine sono le definizioni di “cultura” che sono state date, ciascuna con qualche particolarità sua e qualche elemento proprio. Una loro sia pur sommaria rassegna non entra per fortuna nell’oggetto del nostro discorso “pastorale”. Ci limiteremo a indicare soltanto alcuni pochi concetti fondamentali, sufficienti a fare un po’ d’ordine e a portare il minimo di distinzione indispensabile perché non insorgano ambiguità.
I significati di “cultura” atti a farci raggiungere i nostri intenti ci sembrano fondamentalmente tre; questa distinzione ‑ che apparirà ed è largamente opinabile ‑ è quella che ci sembra più funzionale ai fini della chiarificazione pastorale che ci siamo proposti. Attorno a questi tre concetti si organizza la prima parte della nostra esposizione (3).
1 La “coltivazione dell’uomo”
a) Il primo significato ‑ o, se si vuole, il primo gruppo di significati ‑ proviene da una immagine di origine agricola, che viene piegata a esprimere un avvenimento dello spirito: cultura è la “coltivazione dell’uomo nella sua vita interiore” (4).
Nel mondo classico, dove questa idea nasce e si afferma, si è anche universalmente persuasi che tale coltivazione possa e debba attuarsi mediante i “valori assoluti”: coltivazione dell’uomo mediante il vero, il bene, il giusto, il bello. Solo la verità, la bontà, la giustizia, la bellezza sanno nutrire l’uomo, l’aiutano a crescere, ne fanno sbocciare tutte le virtualità.
Questa coltivazione comprende anche la “paideia”, cioè l’educazione integrale dell’uomo nella sua prima età; ma non si esaurisce in essa: prosegue per tutto l’arco dell’esistenza. Inoltre non esclude, anzi formalmente suppone, la possibilità che l’uomo attenda alla coltivazione di se stesso (5).
b) Quasi inavvertitamente si passò poi a intendere per “cultura” non solo l’azione in se stessa della “coltivazione dell’uomo”, ma anche il suo risultato. La parola prese perciò a indicate il patrimonio spirituale acquisito di cui è dotata una persona.
E, in conformità con la visione classica, tale patrimonio fu individuato nei valori acquisíti di natura intellettuale, morale ed estetica, onde lo spirito è stato arricchito dalla “coltivazione” (6). Fin verso la metà del secolo XVIII non si conoscono altri contenuti del vocabolo. Esso, come si vede, è sempre fin qui riferito alla vita personale del singolo.
c) Con l’esaltazione dell’idea di popolo e di nazione, la parola “cultura” acquista una dimensione, per così dire, “sociale”. E si comincia a parlare della cultura di un paese, di una gente, di una comunità umana.
In questo senso, la cultura di una società è data ‑dai mezzi “sociali” di coltivazione dell’uomo e dai suoi risultati “sociali”; e cioè: prima di tutto dalle sue scuole, dai suoi istituti di ricerca, dai suoi mezzi di comunicazione e di diffusione delle idee; poi dalla sua produzione letteraria, artistica, musicale, e, più ampiamente e profondamente, dal possesso “sociale” dei “valori” di verità, di giustizia, di bellezza.
2 La “elaborazione da parte dell’uomo”
Dalla seconda metà del secolo scorso, a partire dal linguaggio delle discipline antropologiche ed etnologiche, avviene una vera e propria rivoluzione nel significato di “cultura”.
L’uomo entra ancora come elemento determinante del concetto, ma non più come il destinatario e il termine di un’azione, bensì come il soggetto e il principio. I valori assoluti oggettivi, sempre implicitamente presenti nell’antica accezione, perdono di rilevanza e sono alla fine estromessi: per avere attinenza con la “cultura” intesa così basta l’origine umana.
Il vocabolo comincia dunque a indicare tutto e comporta dunque una “scala di valori” proposta e accettata entro una determinata comunità. E poiché le “scale” spesso vengono líberamente e perfino arbitrariamente stabilite, molte e diverse possono essere le “culture” presenti in una società, ciascuna delle quali è identificabile per i valori che essa ritiene primari.
E’ opportuno qui segnalare la radice di una grave e frequente prevaricazione. Se si identifica la “cultura” nella propria gerarchia di valori, è facile cadere nella tentazione di definire incolto, rozzo, subculturale chi si rifiuta di conformarvisi. Dove è evidente l’uso ambiguo della parola “cultura” e la riassunzione surrettizia della sua accezione classica in funzione di condanna, di squalifica o addirittura di insulto. Allo stesso modo, capita spesso di trovare definito con spregio come “dogmatica” o “integralista” la posizione di chi è coerente coi propri princìpi, quando questi princìpi sono diversi da quelli di chi si arroga il diritto di sentenziare. In realtà, è storicamente rilevabile che le culture dominanti si succedono mediante l’accettazione e il ripudio di “valori primari”, che senza dimostrazione vengono accolti e senza confutazione vengono abbandonati. Così, nella scena italiana di questo secolo si è potuto ammirare il prevalere via via di una cultura positivista, di una cultura idealista, di una cultura marxista, di una cultura radicale, tutte con la persuasione di esser molto “critiche” e tutte ugualmente asseverative di “certezze iniziali” ritenute indiscutibili e proposte come dogmi di fede, quasi potessero appellarsí a qualche divina rivelazione, della quale noi profani non abbiamo mai avuto notizia.
II La giusta idea della fede
Anche l’altro termine del binomio che ci sta interessando ‑ la fede ‑ postula qualche piccola analisi chiarificatrice. Qui però non si tratta di cogliere e di distinguere le diverse accezioni, come a proposito della parola “cultura”, per la quale la varietà dei significati trova nell’uso la sua piena legittimità. Qui bisogna cercare di capire che cosa sia oggettivamente la fede entro l’autentica visione cristiana. Ogni divergente concetto, che oggi sia in circolazione tra gli uomini, va giudicato per quello che è: un travisamento, un’alterazione o una mutilazione dell’idea originaria. In realtà, di solito proprio di mutilazioni si tratta. Talvolta la fede è identificata nel complesso delle costumanze rituali, con l’esclusione di ogni partecipazione dello spirito. Oppure è risolta nel sentimento religioso, non illuminato da alcuna plausibile razionalità. Analogamente, è una mutilazione il pensare la fede come fatto meramente conoscitivo, che chiami in causa solo le facoltà intellettuali; ed è una mutilazione ritenerla il risultato di un processo solo volontaristico.
1 Una risposta totale
La Rivelazione ci dice che la fede è una risposta, e può essere capita soltanto se è riferita all’íntervento salvífico del Creatore nella nostra storia.
Credere è accoglimento del Dio che ci vuole non solo destinatari ma anche interlocutori e in qualche modo consorti; è accoglimento personale di un Dio che entra nella vicenda non con la parzialità della creatura, ma con la totalità che è propria della divinità: Dio, che è tutto, vuole una risposta integrale. Nella fede perciò tutto l’uomo ‑ ragione, volontà, sentimento, mentalità, cultura, vita ‑ si apre a Cristo, il Signore crocifisso e risorto nel quale tutta la divina dinamica della salvezza si compendia.
2 Una risposta trasformante
Quando accoglie Cristo e diventa interlocutore del Dio che salva, l’uomo si trasforma integralmente. Si trasfigura e si eleva la sua capacità di conoscere, dal momento che credere vuol dire in definitiva vedere Dio, l’uomo, le cose, con gli occhi di Cristo. Nasce nel credente, con la speranza, una nuova capacità di tendere fiduciosamente alla pienezza di vita e di gioia. Gli è dato, secondo la parola del profeta, un “cuore nuovo”, cioè un’altra e ben diversa facoltà di amare: di amare il Padre, di amare i fratelli, di amare ogni creatura. Questa è la virtù teologica della carità, che ci unisce e assimila al Signore Gesù, immagine viva del Padre, archètipo di ogni uomo, somma di ogni bellezza e di ogni valore che nella molteplicità delle cose si dispiega. L’uomo che crede è insomma un “uomo nuovo”, secondo la parola di Paolo: “Se qualcuno è in Cristo, è una creazione nuova”
3 Una risposta principio di trasformazione del mondo
La fede, creando l’“uomo nuovo”, pone le premesse di un mondo nuovo. L’“uomo nuovo” ovviamente è principio di un comportamento nuovo e diverso in tutti i campi: nuovo si fa il suo modo di esistere, di lavorare, di soffrire, di gioire, di associarsi, di attendere alla umanizzazione della natura.
Già nell’ordine naturale l’uomo non attua pienamente la sua umanità restando racchiuso nell’intimità della sua coscienza; perciò anche la fede, che è atto dell’uomo totale, non può restare confinata nel segreto dei cuori, ma irradia la sua novità in ogni angolo dell’universo.
L’uomo nuovo tende per impulso intrinseco e connaturale a costruire una società nuova, una nuova storia, una nuova cultura.
4 Una risposta ecclesiale
Non si capirebbe adeguatamente né la fede né l’“uomo nuovo” che ne consegue, se non si ricordasse che la “novità” cristiana è certamente un evento personale, che ogni credente assimila in modo proprio, ma al tempo stesso è principio e ragione di una compaginazione che dà origine a un organismo.
Il credente, connettendosi vitalmente con Cristo, si connette vitalmente anche coi suoi fratelli di fede.
Cosi nasce quello che Paolo con immagine audace chiama il “corpo di Cristo”; cosi comincia a vivere e a operare nella storia il mistero della Chiesa.
La risposta adeguata allintervento salvifico di Dio è una Chiesa, cioè una umanità nuova. Ogni interpretazione puramente individualistica del fatto cristiano lo tradisce in uno dei suoi aspetti essenziali.
5 Una risposta contrastata
L’iniziativa divina si imbatte da sempre nell’enigma della resistenza e del rifiuto. “E’ venuto in mezzo ai suoi, e i suoi non l’hanno accolto” (10).
La fede convive con l’incredulità; l’uomo vecchio e l’uomo nuovo coesistono anche dentro lo stesso cuore; la “umanità nuova” non è mai tutta l’umanità; la Chiesa e il “mondo” (nel senso negativo che il termine ha negli scrittori neotestamentari il più delle volte) si fronteggiano e si combattono con alterna vicenda.
Il credente sa che Cristo ha già vinto; ma sa anche che la piena manifestazione di questa vittoria sarà un dono escatologico. Questo non lo scoraggia né lo disarma: per essere se stesso e accogliere totalmente nella verità la salvezza di Dio, egli instancabilmente si adopera a dar vita alla nuova società, alla nuova storia, alla nuova cultura.
III La fede che si fa cultura
A questo punto, chi voglia accostare l’idea di fede, che molto rapidamente abbiamo voluto richiamare, con le varie nozioni di cultura presenti nell’uso corrente si avvede subito che l’interrogativo circa la possibilità e la necessità di una cultura cristiana ha evidentemente una risposta positiva, quale che sia tra i molti il significato di cultura che si prenda a considerare. E con questa conclusione il discorso sarebbe finito.
Ma gli intenti pastorali che muovono la nostra riflessione ci spingono a ricercare la concretezza degli esempi operativi e delle proposte da offrire all’attenzione della comunità cristiana. Basterà ripercorrere passo passo la rassegna semantica che ha costituito la prima parte della nostra esposizione.
1 La “coltivazione cristiana dell’uomo”
La fede cristiana, oltre a donarci una “teologia antropologica”, fondata sulla rivelazione di Cristo uomo, immagine perfetta di Dio, ci regala anche una “antropologia teologica”, che ritrova nell’Uomo‑Dio l’archètipo di ogni reale umanità. Anzi, solo a questo splendore di verità si illuminano pienamente la nostra condizione e il nostro destino: “Solamente nel mistero del Verbo incarnato trova luce il mistero dell’uomo” (11).
Sicché è chiaro che l’autentica e perfetta “coltivazione dell’uomo” è la “coltivazione cristiana dell’uomo”. Dobbiamo tutti ricordare che, secondo la parola di Gesù, il primo e vero e unico coltivatore dell’uomo è il Padre (cfr. Gv 15, 1): ogni altra “cultura” ‑ che non sia almeno oggettivamente e incoativamente espressione e avveramento di quella del Padre ‑ rischia sempre di essere arbitraria e manipolante. Anche la “coltivazione cristiana” si avvarrà, come ha sapientemente intuito la conceziòne classica di cultura, del vero, del giusto, del bello. Anzi, questi valori potranno e dovranno dal credente essere ricercati e assimilati per se stessi, senza inutili sacralizzazioni, nella certezza che, quando sono autentici, sempre essi di avvicinano e ci conformano a Cristo, che è la verità, la giustizia, la misericordia, la bellezza, misteriosamente divenute figura e realtà d’uomo attingíbile e viva.
2 Il “patrimonio spirituale cristiano”
Nei duemila anni della nostra storia, molti contributi decisivi dati alla elevazione interiore dell’uomo e molti tra i frutti più nobili e preziosi dello spirito in tutti i campi (letteratura, arti figurative, musica, diritto, folklore ecc.) portano incancellabili in sé i segni della loro origine dalla visione cristiana.
Questo è il nostro “tesoro di famiglia”. Anche se indubbiamente, in quanto opera dell’uomo, è registrato altresì nel patrimonio di tutta l’umanità, è pur vero che ciò che è nato dalla fede appartiene in modo eminente e più intenso a coloro che condividono la stessa concezione del mondo e la stessa esperienza di vita. Il problema per noi è quello di ridivenire consapevoli della nostra ricchezza. I nostri “grandi” devono tornare a essere veri e attuali maestri, e devono tornare a essere “nostri”. 1 nostri capolavori devono costituire per noi il nutrimento inesauribile dell’anima. La comunità cristiana deve riconquistare la coscienza degli altissimi valori che, nel corso della sua lunga storia, sono originati dal suo seno e restano perennemente vivi.
Va poi notato, a prevenire ogni possibile equivoco e ogni tentazione di interiore grettezza, che dobbiamo apprezzare e avvalorare come alimento dell’anima ogni rilevante fatto dello spirito nel quale brilli qualche raggio di verità, di giustizia, di bellezza, dovunque appaia e comunque si manifesti.
Nel pieno rispetto delle concezioni immanenti e delle intenzioni esplicite di tutti gli autori, anche di quelli che sono stranieri alla nostra fede, noi sappiamo e vogliamo sempre ricordare che ogni verità, ogni giustizia, ogni bellezza ‑ in quanto oggettivi riverberi della luce di Cristo, che è la somma di tutti i valori ‑ è sempre anche nostra, e può e deve armoniosamente confluire nell’autentica cultura cristiana.
Nella nostra evasione dall’Egitto del “mondo”, come già fecero gli ebrei nell’ora dell’esodo, possiamo e dobbiamo portare con noi l’argento e l’oro degli egiziani
3 I mezzi per la “coltivazione cristiana dell’uomo”
La “coltivazione cristiana dell’uomo”, se non vuol restare soltanto un’astratta affermazione di principio, deve avere i mezzi per il raggiungimento dei propri compiti.
Di fronte a uno Stato che sempre più estesamente occupa gli spazi di vita e si impadronisce degli strumenti di comunicazione e di socializzazione (in palese contrasto col “principio di sussidiarietà”, che è uno dei cardini di una concezione sociale che voglia fondarsi sulla libertà e sulla responsabilità della persona), questo argomento è di eccezionale gravità, e andrebbe estesamente trattato.
Ci limitiamo ad alcune poche e semplici osservazioni.
a) Non bisogna stancarsi di affermare il dovere dello Stato di offrire a tutti i raggruppamenti di cittadini (tra i quali c’è la comunità cristiana) la concreta possibilità di educare i figli secondo le proprie fondamentali convinzioni. Chi ha dato la vita, ha il diritto inalienabile di presiedere al suo sviluppo intellettuale e morale. Lo Stato italiano è su questo punto inadempiente da sempre, soprattutto per la sua legislazione scolastica pesantemente statalista.
b) Allo stesso modo, in una società veramente libera che non aspiri a diventare un regime, il potere pubblico non deve tanto imporre una propria cultura, quanto aiutare e favorire in tutte le maniere le culture di tutte le libere aggregazioni.
c) Le comunità cristiane, pur nella loro estrema povertà, devono darsi da fare per la sussistenza, la crescita, l’affermazione della loro cultura, in tutti i modi che una fantasia stimolata dalla fede è in grado di escogitare. Abbiamo nel mondo di oggi esempi eloquentissimi di quanto possa essere fecondo uno spirito vivace e forte, anche quando è tiranneggiato, umiliato e posto nelle condizioni più sfavorevoli. Valga per tutti il fenomeno stupefacente del “samizdat” russo (12).
4 Gli “elaborati” della cristianità
Una “cultura” nel senso, per così dire, antropologico‑etnologico che s’è visto ‑ e cioè tutto il complesso degli elaborati umani ‑ va riconosciuta a ogni raggruppamento di persone che è individuabile come tale. 1n essa trovano posto le tradizioni, le costumanze, gli istituti, le forme di lavoro e di vita, il folklore, i prodotti dell’ingegno e dell’abilità manuale, che una determinata gente riconosce come proprio.
Esiste, intesa secondo questo significato, una “cultura cristiana”? Evidentemente la risposta a questa domanda dipende da una questione previa: esiste un popolo cristiano percepibile e identificabile? O, che è lo stesso, esiste una “cristianità”?
Già da più di una trentina d’anni la cristianità è stata proclamata defunta. E’ un fenomeno, si è detto, di origine “costantiniana”, che ha raggiunto il suo culmine nel Medio Evo e che nel nostro secolo si è del tutto esaurito.
Anzi, con l’affermazione della sua estinzione storica si è accompagnata spesso la proclamazione della sua illegittimità o almeno della sua inopportunità di principio. L’idea stessa di “cristianità” sarebbe oggi improponibile e la Chiesa non dovrebbe mai mirare a dare origine, mediante strutture caratteristiche, a una propria e specifica socialità che la renderebbe un corpo estraneo nel mondo; essa deve solo provocare e sostenere un impegno personale, lucidamente cosciente e del tutto libero da condizionamenti esteriori. E si è parlato di “presenza molecolare”, come della sola forma accettabile e augurabile di insediamento dei cristiani nel sociale.
Mi sembra doveroso notare che questa concezione, che ha del vero in ciò che afferma, non è sostenibile in ciò che rifiuta. E vero che occorre formare delle forti personalità cristiane in grado di vivere totalmente immerse nella società che di fatto oggi esiste; ed è vero che vi possono essere dei cristiani che della “presenza molecolare” fanno un programma di vita, purché mantengano acutissimo il senso della propria identità di credenti e irriducibile la propria originalità di testimoni del Vangelo.) Ma non è vero che questo sia l’unico modo augurabile di presenza né che sia condannabile il tentativo di dar vita a una comunità cristiana anche sociologicamente individuabile.
Almeno tre osservazioni ‑ di genere diverso ma tutte cospiranti a difendere l’idea di un popolo di Dio percepibile come popolo, sia pure “sui generis” ‑ sono da opporre ai denigratori cristiani della cristianità.
La prima è di indole storica. L’aggregazione dei credenti secondo un modulo originale ed esteriormente identificabile di convivenza intensa e operosa è un fatto che si accompagna a tutta la storia ecclesiale fin dai primissimi tempi. La comunità di Gerusalemme, come appare dagli Atti, e le comunità paoline, come si intravvedono nelle lettere dell’Apostolo, sono senza dubbio vere e proprie “cristianità”, anche se di minoranza: in esse i discepoli di Gesù vivevano sotto molti aspetti “a parte” rispetto al resto dei loro connazionali e avevano forme associative tipiche e inconfondibili.
Non c’è epoca nella quale la Chiesa non abbia dato origine a una qualche sorta di “comunità” tra i suoi componenti.
C’è poi un rilievo di carattere psicologico‑pastorale. L’uomo, in forza della sua stessa natura, tende necessariamente a un’esistenza “sociale”. Ciò che non è socializzabile e non diventa mai socializzato, a poco a poco perde di rilievo nella coscienza della maggior parte dei singoli e alla fine si estingue.
Ci può essere forse qualche intellettuale che si ritiene capace di una fedeltà ai suoi ideali che sia puramente individuale, interiore, invisibile.
Ma gli uomini comuni per tener deste le loro convinzioni le devono esprimere in qualche attuazione esteriore e comunitaria, che si imponga all’attenzione anche degli altri.
Infine c’è una ragione teologica decisiva.‑ La natura stessa dell’avvenimento cristiano esige che la “comunione” ‑ che è personale, trascendente ed eterna ‑ aspiri continuamente e instancabilmente a farsi “comunità”, cioè una realtà collettiva, contingente, storicamente determinata. L’atto di fede chiede ‑ per intrinseco dinamismo ‑ di investire e trasformare tutto l’uomo in tutte le sue dimensioni, personale, familiare, sociale.
In nessun momento della sua vicenda la Chiesa può mancare di dare vita a una “cristianità”, secondo forme che mutano nei tempi e nei luoghi, ma che non possono venire meno in assoluto. Perciò il problema vero diventa quello di rinvenire la forma che meglio conviene al nostro tempo (14).
La nostra “cristianità” potrà anche essere di minoranza, diversamente da quella di qualche secolo fa, ma non per questo deve essere meno vivace e meno fortemente caratterizzata. E non potrà mai delinearsi come un evento privo di continuità nel tempo, senza premesse e senza radici: essa sarà tanto più vitale ed “energica” quanto più sarà avvalorata e ispirata non solo dai principi eterni del Vangelo ma anche dalla continua memoria del suo passato.
Come si vede, il rilancio di una “cultura cristíana” così intesa è condizionato dalla ravvivata consapevolezza dell’esistenza di un “popolo cristiano”, con la sua storia, le sue consuetudini,
le sue feste, le sue opere, le sue multiformi manifestazioni (15).
5 La “scala cristiana dei valori”
L’uomo, che non viva del tutto svagato, non può evitare di interrogarsi circa i “valori”; anzi, non può non determinare, almeno nella concretezza delle sue scelte esistenziali, quali siano per lui i “valori” e come vadano gerarchizzati. Quando queste determinazioni sono condivise da tutto un raggruppamento umano che arriva a riconoscere una scala di valori comunemente accettata, sorge e a poco a poco si configura una “cultura”, secondo il significato che s’è visto sempre più largamente diffuso negli ultimi decenni.
Ritengo che, una volta chiarito il termine secondo questa accezione, nessun credente possa contestare l’esistenza e la necessità di una “cultura cristiana”, a meno di ridurre il cristianesimo a pura esteriorità folkloristica o a fatto di coscienza, senza alcuna risonanza oltre la vita segreta dell’individuo.
Piuttosto il discepolo di Gesù dovrà prepararsi in questo campo ai conflitti e agli scontri.
Potrà talvolta rallegrarsi di concordanze inattese con chi non crede, nell’esaltazione di qualche valore. Ma più frequentemente dovrà registrare ‑ senza stupore e senza panico ‑ le più stridenti dissonanze. E’ molto difficile che convergano sulla stessa scala di valori coloro che affermano e coloro che negano un disegno divino all’origine delle cose; coloro che affermano e coloro che negano una vita eterna oltre la soglia della morte; coloro che affermano e coloro che negano l’esistenza di un mondo invisibile, di là dalla scena variopinta e labile di ciò che appare; coloro che credono e coloro che non credono nel Signore Gesù, crocifisso e risorto, Figlio unico e vero del Dio vivente, Salvatore dell’universo. Le comunità cristiane devono affrontare a occhi aperti, con serenità e con vigore di spirito, le inevitabili tensioni tra le diverse “culture” che di fatto convivono nell’ambito di una società pluralistica.
Noi non dobbiamo e non vogliamo imporre a nessuno né con la forza né con l’astuzia la nostra “cultura”, cioè la nostra gerarchia di valori. Ma non possiamo e non vogliamo tollerare che l’imposizione, con la forza o con l’astuzia, di una “cultura” estranea ci snaturi e ci impedisca di esistere e crescere come popolo di Dio, redento dal sangue di Cristo, secondo la visione della vita che noi liberamente e razionalmente accogliamo nell’atto di fede.
Conclusione
“Cultura” è, come s’è visto, parola dai contenuti molto diversi, tutti ugualmente presenti e attivi nel linguaggio e nella mentalità del nostro tempo. L’esame fin qui compiuto ci porta a concludere che, quale che sia tra questi il significato considerato, è da riconoscere la proprietà concettuale, la legittimità e la necessità di una “cultura cristiana”.
In altre parole: il rapporto fede‑cultura non è estrinseco, legato alle circostanze storiche, variabile a seconda dei casi, ma è intrinseco, essenziale, in qualche modo trascendentale.
La fede, restando fede, deve farsi cultura: lo deve a se stessa, alla radícalità e alla totalità del rinnovamento che essa introduce nell’uomo e quindi nell’universo.
Essa non sopprime, non mortifica, non trascura nessuno dei valori autentici che trova al suo dispiegarsi nella storia e nel’ mondo; ma tutti li assume, h purifica, li esalta, li trasfigura in una “cultura” che è nuova e diversa, che sempre si rifonda e si arricchisce, mantenendo la sua tipicità e la sua irriducibilità: li assume, li purifica, li esalta, li trasfigura nella “cultura cristiana”.
Note:
(1) GIOVANNI PAOLO II, Ai vescovi lombardi in visita “ad limina apostolorum”, 15 gennaio 1982. Per un commento di questo documento, cfr. I. BIFFI, Cultura cristiana, Milano 1983, pp. 131‑135.
(2) E. GIAMMANCHERI, La “dimensione culturale” del Pontificato di Paolo VI, in: Paolo VI e la cultura, Brescia 1983, p. 23. Sulle stesse posizioni di Paolo VI e Giovanni Paolo Il era l’arcivescovo di Milano G. COLOMBO, Il cristiano di fronte alla cultura, Milano 1979. Si tratta dell’ultimo dei grandi discorsi programmatici pronunciati il giorno di sant’Ambrogio. Sembra invece scostarsi da questa linea il cardinal Martini, quando descrive il rapporto fede-cultura come non organico e pertanto variabile a seconda delle circostanze: C.M. MARTINI, Fede e cultura nell’insegnamento di Paolo VI, in: Paolo VI e la cultura, Brescia 1983, pp. 13‑16.
(3) Per il concetto di cultura e la sua storia, cfr. P. Rossi, Cultura, in: Enciclopedia del Novecento, 1, 1143‑1157. Il Concilio Vaticano Il sembra aver presente soprattutto il primo e il secondo concetto di cultura (Gaudium et spes, 53‑62).
(4) Già Cicerone e Orazio parlavano di una “cultura animi”.
(5) In questa visione “classica” è implicita la convinzione che l’uomo abbia bisogno di una “coltivazione” e che il modo giusto di educare non sia quello di lasciare che il bimbo cresca “come vuole”; ed è implicitamente riconosciuta anche l’esistenza di “valori oggettivi”, necessariamente coinvolti nell’opera educativa. Il limite di questa immagine “agricola” è di non esprimere a sufficienza la “non passività” di colui che è destinatario della “coltivazione”.
(6) Va notato che qui non siamo di fronte a un sinonimo di “erudizione” in quanto il termine “cultura” vuole indicare non solo l’aggregazione di notizie sparse e reciprocamente indipendenti, ma anche ‑ in qualche modo ‑ la loro composizione in una sintesi organica, illuminata sui nessi e sulle cause dei diversi fatti dello spirito. Nell’uomo “colto” si suppone cioè una certa presenza dell’azione unificante dell’intelligenza; il che non è di per sé richiesto per assegnare a un uomo la qualifica di “erudito”.
(7) L’evoluzione semantica avviene fino a questo punto tra concetti, per così dire, contigui, mediante accentuazione dell’uno o dell’altro di quegli elementi che in qualche modo sono dall’inizio tutti implicati. E dunque una variazione che resta nell’ambito di contenuti affini e connessi.
(8) All’interno di questo concetto si danno variazioni importanti in sé e per gli influssi che hanno avuto. Così Spengler riserva il termine “cultura” alle forme di convivenza che sono arrivate alla “esistenza storica”, cioè alle civiltà, e le connette col sorgere della città. Su questo concetto costruisce la sua teoria dei cicli vitali delle civiltà e del loro inevitabile tramonto. Su questa linea si muove anche Toynbee, per il quale la civiltà è la risposta adeguata di un raggruppamento umano alla sfida dell’ambiente.
(9) 2 Cor 5, 17.
(10) Gv 1, 1 L
(11) Gaudium et spes, 22. 12 Cfr. Es 12, 35.
La conoscenza della “chiave” esatta di comprensione dell’universo concretamente esistente ci consentirà, di ogni rilevante fatto dello spirito, una lettura più compiuta e più penetrante di quanto non sia stata possibile in chi ne è stato il principio. Possiamo cogliere la “verità” delle opere di Aristotele e di Platone più di Aristotele e di Platone; possiamo percepire la bellezza trascendente dell’Antigone o delle Bucolicke più di Sofocle e di Virgilio; possiamo accedere agli ideali di giustizia e di solidarietà umana espressi nelle varie dichiarazioni costituzionali fino a una profondirà ignota agli stessi estensori.
E in sostanza la valorizzazione della “intentio profundior” degli autori, di cui parlava già Tommaso d’Aquino.
(12) Sul “samizdat”, cfr. j. MAL’CEV, L”altra letteratura” (1957^1976), Milano 1976.
(13) Il Daniélou ha per primo denunciato il carattere astratto e maldestramente aristocratico delle denigrazioni della cristianità, rilevandone soprattutto l’ingenuità psicologica: “A molti cristiani l’idea stessa di cristianità appare definitivamente superata... Ma bisogna pesare le conseguenze di tale opzione. E’ troppo evidente che questo è un punto sul quale bisogna insistere: non è possibile agli uomini nel loro insieme ‑ dico a tutti gli uomini ‑ essere cristiani quando si trovano in un ambiente indifferente o ostile al cristianesimo. Ciò deriva da una legge molto semplice della psicologia, radicalmente misconosciuta da un certo numero di teologi contemporanei che sono degli idealisti puri. Essi ragionano come se la libertà non fosse affatto condizionata... Mi angoscia attualmente il fatto che alcuni teologi sostengano piuttosto l’idea di sbarazzarsi del popolo cristiano, perché trovano che esso rappresenti ciò che loro chiamano un "cristianesirno sociologico", che disprezzano; e mi angoscia anche che essi mettano l’accento solo su un cristianesimo personale che non può essere che un cristianesimo di élites. Questa mi pare una concezione assolutamente unilaterale delle cose...” (J. DANIELOU, Cattolicesimo, in: Enciclopedia del Novecento’ 1 I, pp. 666 s.).
(14) E’ possibile che nel dibattito circa la “cristianità” si introduca tal volta un equivoco, e il termine non venga sempre usato univocamente.
Se per “cristianità” si intende la perfetta coestensione (che, ovviamente, non vuol dire coincidenza) della Chiesa con la società civile, allora è giusto dire che oggi non esiste più: a differenza di altre epoche, in cui praticamente tutti i cittadini si riconoscevano appartenenti anche all’organismo ecclesiale, oggi solo una parte si attribuisce tale appartenenza.
Se invece il vocabolo designa la traduzione sociale ed esteriormente percepibile del mistero ecclesiale, allora la cristianità è un valore di sempre e va concettualmente difeso, anche se non in ogni epoca e in ogni luogo è un fenomeno “di maggioranza”.
(15) sostenitori della “presenza molecolare” sono soliti citare a conforto della loro tesi il paragone evangelico, del sale (Mt 5, 131 e la Lettera a Diogneto che parla dei cristiani come “anima del mondo”. E’ chiaro da questi testi, si dice, che la comunità cristiana non può essere un’aggregazione “a parte”; piuttosto deve essere una presenza dinamica e invisibile, sciolta all’interno della società. In tutti e due i casi, però, siamo di fronte a una lettura che alla luce dei contesti rivela subito la sua parzialità e la sua origine ideologica.
Quanto al “sale”: non si può ricordare l’immagine del “sale” del versetto 13 e passare sotto silenzio quella della “città collocata sopra un monte” del versetto 14; ma soprattutto è evidente che Gesù cita l’immagine del sale per insegnarci non come si debba essere presenti nel mondo, ma quanto sia necessario conservare la propria identità, se si vuol davvero giovare al mondo: il sale che ha perso la sua natura di sale “a null’altro serve che a essere gettato via e calpestato dagli uomini”.
Quanto a Diogneto: è da notare che il paragone dell’anima e del corpo non va letto alla luce dell’antropologia tomista (prevalente nei Teologi del secolo ventesimo), ma entro la prospettiva platonica (propria dell’autore), che vede l’anima come una entità a sé, prigioniera del corpo e in lotta perpetua col suo carceriere (come esplicitamente ricorda il testo, VI 5). Vi si dice senza dubbio che i cristiani in ogni nazione sono in patria (e perciò non hanno una patria geograficamente identificabile, V 5); ma vi si dice anche che presso ogni popolo sono un corpo estraneo (e perciò non perdono l’identità della loro specifica aggregazione). Sono dunque una “politèia” (società) sì “paràdoxos” (insolita, strana, sorprendente), ma sempre “politèia”, inconfondibile e inassimilabile (V, 4).

Fraternamente CaterinaLD
"Siamo mendicanti e chiediamo agli altri anche le loro idee, come la staffetta della posta che riceve il documento dalle mani di uno e poi corre per darlo ad un altro. Faccio una timida parafrasi delle parole di chi ci ha preceduto nel cammino della fede, per annunciarle ad altri."
(fr. Carlos Alfonso Azpiroz Costa OP
Maestro dell’Ordine) |
| | | OFFLINE | Post: 39.988 | Sesso: Femminile | |
|
 17/06/2016 11:10 17/06/2016 11:10 | |
IL RICORDO
L'uscita di un libro che raccoglie diversi interventi in onore del cardinale Giacomo Biffi, ricorda l'ormai prossimo primo anniversario della morte dell''arcivescovo di Bologna (11 luglio). Oltre a proporvi a parte un brano del libro, abbiamo chiesto a monsignor Luigi Negri, che lo ha conosciuto bene, un breve giudizio sull'opera del cardinale Biffi.
- IL CARDINALE CHE DIFFONDEVA CERTEZZA,
di Giuliano Ferrara
di Luigi Negri*
L'uscita di un libro che raccoglie gli interventi di importanti personaggi in onore del cardinale Giacomo Biffi, ricorda l'ormai prossimo primo anniversario della morte dell''arcivescovo di Bologna (11 luglio). Oltre a proporvi a parte un brano del libro edito da Cantagalli (clicca qui), abbiamo chiesto a monsignor Luigi Negri, arcivescovo di Ferrara, che lo ha conosciuto bene, un breve giudizio sull'opera del cardinale Biffi.
Con l'avvicinarsi del primo anniversario della morte del grande cardinale Giacomo Biffi condivido volentieri alcuni pensieri per rievocarne la straordinaria figura.
Biffi ha dominato il suo tempo, ha servito la Chiesa con una chiarezza intellettuale insuperabile, con una capacità pastorale che si scopre e si riscopre man mano che il tempo passa. La raccolta dei suoi interventi pastorali per la diocesi di Bologna comincia ad essere, per me, un classico della riflessione pastorale.
Ha servito la Chiesa come ultimo fra gli ultimi; ma in questo suo essere servo della Chiesa di Dio, lo ha fatto con la grandezza intellettuale e morale che lo caratterizzava e che ne fa uno dei cristiani più grandi di questo secolo, ma soprattutto uno dei più grandi maestri. Ha dominato il suo tempo lavorando prima a Milano e poi a Bologna, due città singolarmente martoriate dal dilagare della mentalità laicista anticattolica, decisamente avversa alla stessa esistenza della Chiesa.
Ha dominato sottolineando con molta chiarezza che ogni attacco portato alla Verità e alla Libertà della Chiesa sarebbe diventato, come purtroppo è apparso chiaro in questi ultimi anni, un attacco al popolo. Alla persona e al popolo; il popolo umano, che anziché essere accudito da coloro che gestiscono il potere, viene progressivamente e programmaticamente vilipeso.
Grande uomo di Chiesa e padre della patria. Io credo che in questo, senza esagerazione, consista la sintesi straordinaria di quest’uomo del quale tutti, poco o tanto, e io per primo, ci siamo sentiti umili discepoli.
* Arcivescovo di Ferrara-Comacchio
 Fraternamente CaterinaLD
"Siamo mendicanti e chiediamo agli altri anche le loro idee, come la staffetta della posta che riceve il documento dalle mani di uno e poi corre per darlo ad un altro. Faccio una timida parafrasi delle parole di chi ci ha preceduto nel cammino della fede, per annunciarle ad altri."
(fr. Carlos Alfonso Azpiroz Costa OP
Maestro dell’Ordine) |
| | | OFFLINE | Post: 39.988 | Sesso: Femminile | |
|
 12/07/2016 20:05 12/07/2016 20:05 | |
Pubblicato il 12 lug 2016
Registrazione dell'omelia del Card. Carlo Caffarra, alla Messa in suffragio del Cardinal Giacomo Biffi, nel primo anniversario della morte. Cattedrale di San Pietro, 11 luglio 2016.
www.youtube.com/watch?v=yLqfHCrHT4o
![[SM=g1740738]](https://im1.freeforumzone.it/up/17/38/687591510.gif)
Fraternamente CaterinaLD
"Siamo mendicanti e chiediamo agli altri anche le loro idee, come la staffetta della posta che riceve il documento dalle mani di uno e poi corre per darlo ad un altro. Faccio una timida parafrasi delle parole di chi ci ha preceduto nel cammino della fede, per annunciarle ad altri."
(fr. Carlos Alfonso Azpiroz Costa OP
Maestro dell’Ordine) |
| | | OFFLINE | Post: 39.988 | Sesso: Femminile | |
|
 02/07/2017 08:59 02/07/2017 08:59 | |
 Biffi racconta Biffi Le lettere di un uomo autentico Biffi racconta Biffi Le lettere di un uomo autentico
di Tommaso Scandroglio
02-07-2017

Socrate una volta disse che gli scritti sono come una statua: se interrogati non rispondono. Nemmeno i morti, bisognava rammentargli. Per fortuna quindi che ci sono i libri che ci permettono, se non di interloquire, almeno di ascoltare cosa aveva da dire chi non c’è più.
L’11 luglio del 2015 saliva al cielo il Cardinale Giacomo Biffi, arcivescovo di Bologna per molti anni, e in questi giorni esce per i tipi di Itaca una raccolta di lettere che lo stesso Biffi scrisse nell’arco di più di 50 anni, tra il 1960 e il 2013, ad una carmelitana scalza, suor Emanuela Ghini, (G. Biffi [a cura di E. Ghini], Lettere a una carmelitana scalza, Itaca, 2017). I temi trattati sono dei più vari ma in questo microuniverso di carta sono sempre due i soli che illuminano il pluridecennale e curioso carteggio: Cristo e la Chiesa. Da tale epistolario emerge come il Biffi pubblico sia perfettamente sovrapponibile a quello privato – prova che gli uomini di Dio sono sempre autentici – e come la santità di un uomo faccia rima con semplicità e profondità.
Le recensioni di libri mediocri trovano davanti a sé una strada tutta in discesa. Di converso le recensioni di libri eccellenti sono tutte in salita e non possono che votarsi all’insuccesso perché apparirebbero sempre come pallido riflesso della ricchezza contenuta in essi. E dunque lasciamo la penna volentieri allo stesso cardinal Biffi.
Alcuni ritratti di personaggi noti. Padre Turoldo: “La sua ‘teologia’ è farneticante, la sua abituale frequentazione dei ricchi e dei colti lo induce a farsi annunciatore di una Chiesa povera e semplice. La sua affinità elettiva con chi ha il potere dei mezzi di comunicazione (televisione, Corriere della sera, etc.) gli dà una risonanza e un’amplificazione del tutto sproporzionata e ingiusta”. Don Giuseppe Dossetti: “è stato angosciante l’avvedermi che la sua visione teologica (e particolarmente la sua ecclesiologia) non mi pareva conforme alla Rivelazione ed era ideologicamente condizionata”. Il cardinale Gianfranco Ravasi: “di persona lo conosco poco: mi dà l’impressione che in lui prevalga lo ‘studioso di letteratura ebraica’ sull’ ‘indagatore del disegno di Dio’”. Il cardinale di Milano Giovanni Colombo, verso cui Biffi nutriva grande stima, “continua a ritoccare e a rifare, perché i suoi elaborati (e tanto meno quelli degli altri) non lo appagano mai. Credo che quando entrerà nella visione beatifica, il suo primo giudizio sarà: ‘Pensavo meglio’”. Il cardinale Carlo Caffarra per il quale anche nell’epistolario spese parole bellissime: “siccome nessuno è perfetto, ha due gravi difetti: è completamente astemio ed è tifoso del Milan (per un interista come me è quasi imperdonabile)”.
Pensieri sparsi: “Il discorso sulla Chiesa dei poveri non ha molta eco dentro di me perché né l’ambiente religioso che mi ha cresciuto né quello dove ho finora esercitato il mio ministero è stato composto né di benestanti né di intellettuali”; “Nei fascicoli de ‘Il Regno’ ‘chiesa’ è scritto sempre con la minuscola. […] Ma poi trovo scritto spesso: Comunità metodista, Comunità di base, Camera del lavoro, Consiglio pastorale, Nazioni unite, e qualche volta addirittura Stato, tutti con la maiuscola. […] Perché questo accanimento implacabile solo contro la Chiesa? Perché questo rigore stilistico che solo nei confronti della Chiesa non si distrae mai? […] Questa voluttà di avvilire almeno nell’ortografia la sposa del Signore – che è di molte anche eccellenti persone – meriterebbe a mio avviso un’analisi dell’inconscio”; “Per il pensiero moderno conta più il cercare che il trovare. […] Credo che sia stato Lessing a dire che vale più la caccia della lepre. Ma forse è perché non ha mai mangiato la lepre”; “Quando ho il raffreddore mi riesce impossibile essere un santo. […] Il Signore Gesù – che non aveva avuto la fortuna di leggere le mie pagine – ebbe di fronte al dolore e alla morte paura, noia e tristezza, e chiese di non morire, con preghiere, suppliche, grandi grida e lacrime. […] E ‘fu esaudito per la sua pietà’, da un Padre che, a proposito di esaudire le preghiere dei figli, deve avere un forte senso dell’umorismo”.
“Io non mi sento particolarmente attratto dalle forme del movimento [di CL], ma certo il vedere migliaia e migliaia di studenti universitari che di fronte alla prepotenza del Movimento studentesco parlano di Gesù Cristo come se lo incontrassero tutti i giorni all’ora dell’aperitivo, mi impressiona un po’”; “Gli editori cattolici […] forse identificano i loro interessi con quello del Regno di Dio, e perciò tutti i soldi che sono costretti a sborsare li considerano sottratti al Regno”; “Sono stato nominato vicario episcopale per la cultura, perciò sono molto desolato. La cultura non mi ha mai interessato e cosa debba e possa fare un vicario episcopale non lo so. […] Nel mondo della cultura, mi trovo spaesato. Mi sembra così poco consistente e denutrito. Ma non dirlo a nessuno, se no perdo il mio posto di lavoro”; “La Chiesa non deve essere credibile, ma credente; allora sarà anche credibile”. Rammentando del primo incontro con Suor Emanuela presso il seminario di Venegono, avvenuto anni prima quando lei non era ancora entrata nel Carmelo: “Io, che sono sempre stato tendenzialmente poligamo, certamente ti avrò accolto con gioia come un dono della Provvidenza”.
L’umorismo è “amare appassionatamente tutte le creature senza identificare mai nessuna di esse con il loro Creatore”; “La cosa più comica sono i cattolici impegnati e gli intellettuali in genere, che puntano fieramente i loro fucili dalla parte dove non ci sono più nemici (e dove non si corre alcun pericolo)”; “Il Nunzio apostolico mi ha confidato, nel lussuoso riserbo che di solito circonda le sedi dei diplomatici, che l’Australia è un continente e che davanti al Santissimo Sacramento bisogna fare la genuflessione; ti raccomando di non dirlo in giro”; “Una intelligente flebite mi ha costretto ad attuare per dovere il sogno della mia vita: quello di stare a letto tranquillo senza febbre e senza grandi dolori e di poter disdire tutti gli impegni di lavoro”; “A sentir parlare tanti della comunità primitiva e dell’impossibilità di risalire da essa al Cristo storico, si ha l’impressione che il giorno dell’Ascensione con Gesù siano saliti al cielo tutti i testimoni della sua vita. Sicchè tutto è dovuto ripartire da zero”; “Sai io adoro il conformismo. In un mondo così squinternato, la sola filosofia veramente estrosa e originale mi sembra l’ortodossia”.
Un giorno l’auto su cui stava viaggiando va in panne. Questo contrattempo “ha consentito un’esperienza interessante: un lungo colloquio di più di un’ora, mentre aspettavo il carro attrezzi, tra un vescovo in alta uniforme e i due figli del venditore ambulante di fiori, uno di quattro e uno di sette anni, sull’arduo tema del celibato ecclesiastico. Abbiamo concluso tutti e tre che non ci sposeremo mai, io per ragioni apostoliche e loro perché trovano antipatiche le bambine. Ma penso che col tempo alcuni di noi cambieranno idea”; “Comunque la decadenza che stiamo vivendo è grande. […] Mi pare possa essere paragonata alla crisi che è seguita al concilio di Nicea, quando il mondo ‘si svegliò ariano’: adesso la cristianità si è trovata secolarista, solo che non si è ancora svegliata”.
In merito alla rimessione del mandato dall’incarico di arcivescovo: “il papa mi ha già fatto capire che vorrebbe farmi proseguire ancora un po’, mentre a me sembra opportuno concludere al più presto. Siccome il papa è infallibile, l’aiuterò a non sbagliare; cioè a decidere secondo il mio desiderio”. Relativamente all’elezione di Benedetto XVI: “Scegliendo, in sole ventiquattrore, colui che nell’immaginario collettivo era naturalmente associato alla ‘fede’ e alla sua salvaguardia, il collegio cardinalizio ha detto che, tra i molti e gravi problemi, quello della fede autentica e piena è il primo e il più inderogabile”.
E chiudiamo forse con l’aforisma più significativo di tutto l’epistolario: “Il mondo è una foresta di segni e un’allusione. Tutte le cose alludono all’invisibile”.

[Modificato da Caterina63 02/07/2017 09:00] Fraternamente CaterinaLD
"Siamo mendicanti e chiediamo agli altri anche le loro idee, come la staffetta della posta che riceve il documento dalle mani di uno e poi corre per darlo ad un altro. Faccio una timida parafrasi delle parole di chi ci ha preceduto nel cammino della fede, per annunciarle ad altri."
(fr. Carlos Alfonso Azpiroz Costa OP
Maestro dell’Ordine) |
|
|
|
|